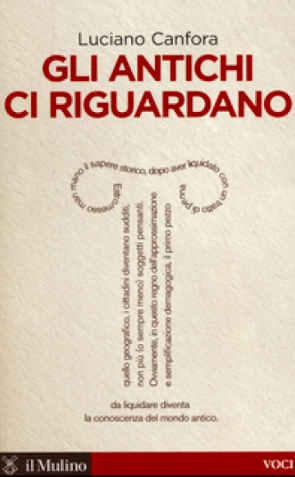Raffaella De Santis
“La Repubblica”, 23 agosto 2014
ORMAI si tengono in inglese gli incontri ufficiali tra uomini politici e le conferenze scientifiche internazionali. L'inglese è il nuovo esperanto, la lingua ufficiale della comunità europea, ma ci sono parole che appartengono alle nostre culture nazionali difficili da tradurre. Ci sono concetti nati in determinate fasi storiche per i quali è complicato cercare equivalenti, e forse inutile. Il tentativo di rendere in altre lingue il tedesco Kitsch ha prodotto scarsi risultati. Tutti conosciamo la parola Pravda, certo. Sappiamo anche che ebbe un discreto successo nell'Unione Sovietica, ma poi ogni paese europeo l'ha tradotta a modo suo: verità o giustizia? Dieci anni fa in Francia la filosofa e filologa Barbara Cassin ha curato un Dictionnaire des intraduisibles per le Éditions de Seuil proprio per sondare affinità e differenze dentro i confini linguistici europei.
Ora questo vocabolario delle parole intraducibili ha la sua versione inglese, grazie al lavoro di Emily Apter, Jacques Lezra e Michael Wood (Dictionary of Untranslatables. A Philosophical Lexicon, Princeton University Press). Nell'introduzione Barbara Cassin spiega che "intraducibili" vuol dire "traducibili all'infinito", cioè suscettibili di tante versioni, tutte quasi esatte ma non completamente esatte. Il risultato mostra che anche da un punto di vista filosofico e concettuale l'Europa non è unita o meglio volendola mettere in positivo – che la sua essenza è nelle differenze, nelle contraddizioni, proprio a partire dalle lingue nazionali. Le voci di questa cartografia filosofica della nostra diaspora linguistica, affidate a oltre 150 collaboratori, tra cui Alain Badiou, Étienne Balibar, Remo Bodei, Rémi Brague, Judith Butler, Gayatri Chakravorty Spivak, partono dalle parole per mostrare come anche le più comuni (stato o governo, ad esempio) di paese in paese abbiano sfumature diverse di significato, legate al fatto che il linguaggio è l'espressione più immediata e sedimentata della cultura di un popolo: quanti tipi di "giustizia" incontriamo spostandoci nello spazio e nel tempo e qual è il concetto di bene legato a lemmi come good, right o bien? Quante facce può avere la verità (aletheia, vérité, truth)? Si può tradurre mind con mente o geist con esprit?
Perfino l'amore non è per tutti lo stesso, anche se la parola love imperversa nelle opere di Jeff Koons e sulle copertine dei bestseller. Naturalmente il modello di questo viaggio filosofico attraverso il lessico rimane il lavoro di Émile Benveniste, Vocabulary of Indo European Institutions. In Italia abbiamo invece il progetto dell'Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee-Cnr, diretto oggi da Antonio Lamarra ma fondato da Tullio Gregory con la collaborazione di Tullio De Mauro nel 1964, che ha dato vita a una collana arrivata oggi al volume numero 122 (edizioni Olschki).
Ogni traduzione è "tradimento" e "trasgressione": a volte per tradurre un termine bisogna ricorrere a una perifrasi perché non esiste un equivalente. Altre volte è difficile rendere parole cadute in disuso e appartenenti ad altri contesti culturali. Non solo da una lingua all'altra ma anche all'interno di una stessa lingua: complicato oggi parlare di "sprezzatura", un tipo di grazia che evita l'affettazione, per lo meno da quando l'eleganza di corte è stata sostituita dalla bellezza da copertina e Mona Lisa rimane solo un ideale da fotografare al Louvre. È vero, il globish, l'inglese semplificato diffuso a livello globale, è leggero, pratico, facilmente ma spesso così lontano dalla lingua inglese reale che i primi a non capirlo sono proprio gli anglosassoni. In rete impazzano i video con l'inglese dei nostri politici, tra cui l'intervento di Matteo Renzi al Digital Venice, che è diventato un video musicale sulle note di Surfin Bird di The Trashman. Ma fuori dai confini di questo inglese incerto continua a esistere una pluralità semantica ineliminabile, una molteplicità di lingue, ognuna portatrice di una visione. La sfida di un dizionario del genere è mostrare che la resistenza alla traduzione di alcuni lemmi può costituire un arricchimento. Scrive Michael Wood nell'Introduzione al Dictionary of Untranslatables : «La Babele può essere un'opportunità, fornendo più prospettive delle stesse cose». Un'Europa lost in translation può diventare dunque una ricchezza, se non pratica almeno cognitiva.