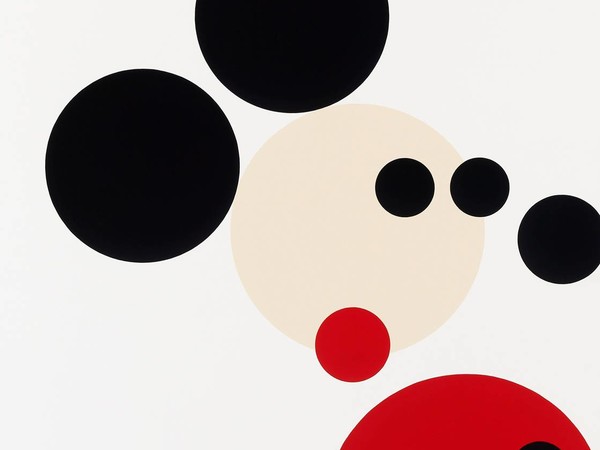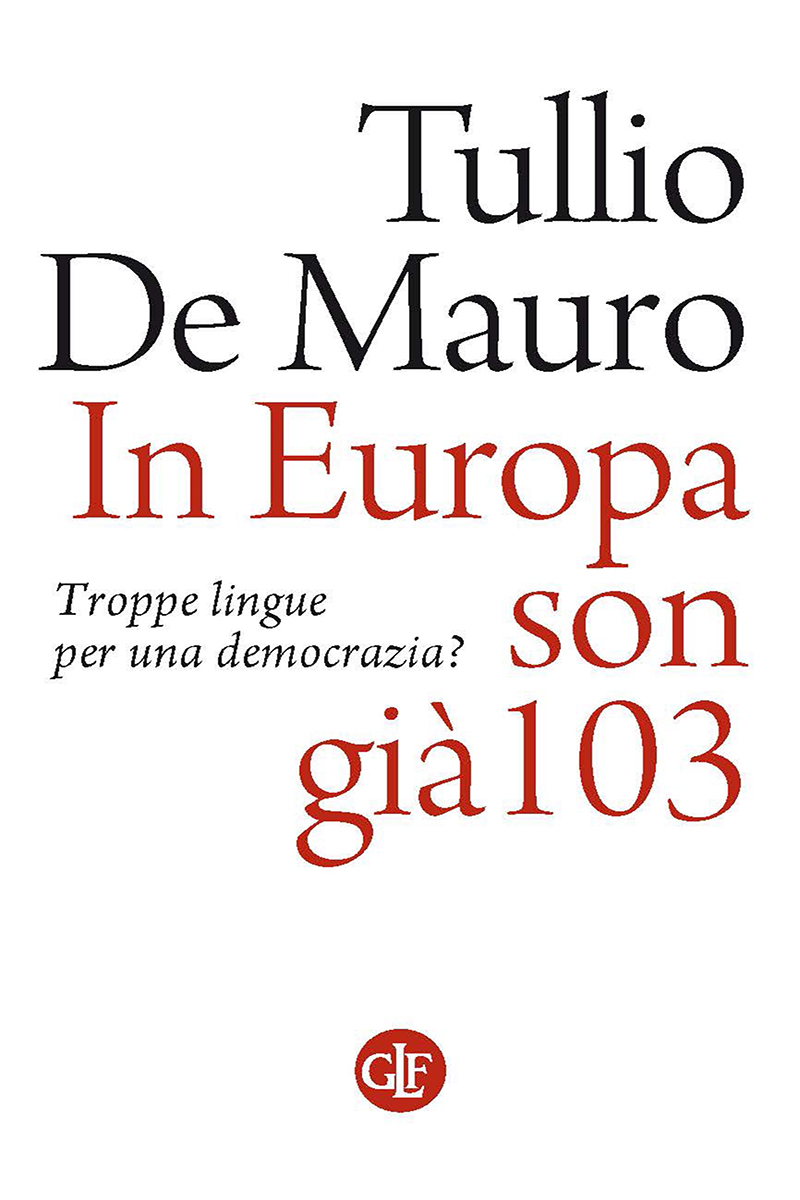La conferenza alla Normale di Pisa per la serie “Virtual immersions in science”
Dall’elettrone alla super-simmetria: perché la storia delle particelle è aperta
Gabriele Beccaria
"La Stampa -TuttoScienze", 26 novembre 2014
A metà della conferenza Riccardo Barbieri, fisico della Scuola Normale Superiore di Pisa, mostra quanto di più vicino ci sia alla rappresentazione del Tutto. Non è un disegno e non è un grafico. È la «slide» di una lunga equazione.
È l’equazione che racchiude tutte le altre, in grado di spiegare il comportamento delle particelle, i «mattoni» di cui l’Universo è fatto e con cui si crea la realtà. «E’ un quadrante della Natura, le cui leggi si possono scrivere in poche righe con precisione assoluta»: la descrive così Barbieri, ricordando che al Cern di Ginevra c’è chi l’ha fatta orgogliosamente stampare sulla t-shirt. Come un manifesto della potenza della ricerca nel XXI secolo.
E allora si arriva al titolo della sua conferenza, organizzata a Pisa il 12 novembre scorso nell’ambito del programma «Virtual Immersions in Science»: «Dall’elettrone al bosone di Higgs: una storia incompiuta?». Risposta. Sì. La storia è ancora aperta. Moltissimo lavoro aspetta i fisici, mentre si aspetta la riaccensione dell’acceleratore «Lhc». Da una parte c’è il Modello Standard - la teoria che racchiude le particelle e le loro interazioni - e dall’altra c’è la cascata delle scoperte delle particelle stesse: dall’elettrone, individuato nel 1897, fino al bosone di Higgs, rilevato nel 2012 proprio al Cern. Ma nel mezzo galleggiano molti interrogativi senza risposta.
«Ci sono delle ragioni fattuali per cui la storia non è affatto conclusa», ha spiegato Barbieri. E queste hanno a che fare con la «torta cosmica»: oggi gli studiosi che indagano l’Universo ne vedono e capiscono all’incirca il 5%. Appena. Il resto è materia oscura ed energia oscura. Un 95% di realtà alternativa che - almeno al momento - non rientra nelle armonie del Modello Standard. Ed è in questo oceano misterioso che il bosone di Higgs si prende il suo ruolo di protagonista, quello che l’ha reso una star sui media del mondo da quando fu annunciata la prova della sua esistenza, due anni fa.
Lo si capisce quando si comincia a descriverlo, seguendo la logica controintuitiva della fisica dell’infinitamente piccolo. Ricordando come nel mondo sub-atomico particelle e onde non siano distinguibili, Barbieri ha spiegato che il bosone di Higgs rappresenta «un campo», vale a dire «una zuppa, estesa in ogni punto dello spazio e in ogni istante del tempo». E il suo «condensato» - così lo si definisce in gergo - dà origine alla massa delle particelle. Il bosone, quindi, è piccolo, piccolissimo, tanto da manifestarsi con una certa riluttanza perfino nelle collisioni all’interno di «Lhc», ma allo stesso tempo è decisivo per tenere insieme il cosmo nella sua vastità, stelle e galassie comprese.
Il bosone di Higgs appare quindi come la colla perfetta per mettere in comunicazione scale di grandezza opposte. Peccato che «il rompicapo» - come lo chiama Barbieri - resti, eccome. «Il valore di questo campo è stato definito nell’esperimento di “Lhc” . Ma, se vogliamo capirlo, spingendoci oltre il Modello Standard, dai calcoli si ottiene un altro valore, decisamente più grande». Il rompicapo va sotto il nome di «Problema della naturalezza» o «della gerarchia» e cerca di spiegare - senza riuscirci - perché la forza gravitazionale sia tanto insignificante nel mondo microscopico rispetto alle forze elettriche. Insomma: «C’è un evidente conflitto tra valori misurati e valori calcolati». Altissimi nel primo caso, piccolissimi nel secondo caso. «Due facce - osserva Barbieri - di una stessa realtà».
A questo punto qual è la strada da imboccare? «Lhc» sta scaldando i suoi iper-tecnologici motori: 27 km di magneti ad anello, che dal 2015 ospiteranno nuove collisioni di protoni. «Vedremo se scoprirà altre particelle. Ogni volta che si aumenta il regime di energia c’è la possibilità di vedere cose nuove. In produzione diretta». Barbieri è uno dei fisici che lavora alla teoria della super-simmetria ed è questa una possibile risposta al rompicapo dei valori troppo grandi e troppo piccoli: se si trovassero altre particelle, «speculari» a quelle già note, ma decisamente più pesanti, si potrebbe dire di aver messo fine al mistero.
«Il meccanismo che ha nascosto fino a oggi le particelle “super-simmetriche” potrebbe essere analogo a quello che spiega un apparente paradosso: mentre nello spazio vuoto le leggi fisiche prevedono che non ci sia distinzione tra elettroni e neutrini, in presenza del campo di Higgs la “simmetria” tra elettroni e neutrini svanisce e di conseguenza i primi e i secondi riprendono una spiccata identità». Ridiventano particelle decisamente diverse. I primi molto comuni e i secondi molto elusivi.
Mezzo secolo dopo, nella stessa sala della Normale dove entrò per la prima volta, Barbieri ha tenuto la sua lezione, spiegando che quando uno scienziato si trova davanti a un pubblico di non specialisti riemerge sempre una domanda, quella finale: «A cosa serve tutto questo?». E le risposte - ha concluso - «sono due. La prima è classica: a molti follow-up, da Internet alla medicina. Ma io preferisco la seconda: Non lo so!». Poi dopo una pausa termina così: «E’ la curiosità per ciò che è superfluo a renderci pienamente umani».
“Anno 2015, viaggio nella materia all’alba del cosmo”
Antonio Lo Campo
E’ un grande momento per la fisica italiana: mentre si festeggia la nomina di Fabiola Gianotti a direttore del Cern, torna a far parlare di sé «Alice», uno degli esperimenti dell’acceleratore «Lhc». I leader storici del test - tra cui l’attuale coordinatore Paolo Giubellino - sono stati insigniti del premio «Lize Meitner» per la Fisica nucleare, assegnato dalla «Nuclear Physics Division» dell’European Physics Society.
Professor Giubellino, perché «Alice» è considerato così importante?
«Ha realizzato un salto di qualità straordinario nella comprensione del comportamento della materia nucleare a densità e temperature estreme».
Che cosa significa in pratica?
«Le ricerche ci portano informazioni essenziali sulle interazioni forti che governano l’Universo, aprendoci la porta su due aspetti-chiave: come si genera dalla massa dei quark quella delle particelle ordinarie, vale a dire di ciò che ci sta intorno? E, quindi, com’era l’Universo nei primi istanti dopo il Big Bang?».
Che cosa avete scoperto?
«Studiando collisioni tra nuclei di piombo a velocità prossima a quella della luce e raggiungendo temperature di 3 mila miliardi di gradi, siamo entrati nel vivo di un programma che ha impiegato mille ricercatori e ora iniziano ad arrivare i risultati. In queste condizioni è possibile osservare la materia primitiva, com’era prima che assumesse le caratteristiche che presenta adesso, in particolare prima che i quark si riunissero a formare i protoni e i neutroni e, da qui, i nuclei degli atomi».
Com’è questa materia?
«I quark e i gluoni, che in condizioni normali sono intrappolati nel nucleo, si “sciolgono” e si liberano in una “zuppa”. Uno dei modelli teorici che descrive il comportamento in questo stato, chiamato “plasma di quark e gluoni”, era stato descritto per la prima volta proprio da due italiani, Giorgio Parisi e Nicola Cabibbo».
E il futuro? Che cosa promette «Alice» per i prossimi anni?
«Nuovi e più importanti risultati. Da febbraio 2015 inizierà la fase “Alice 2.0” che si prolungherà per il prossimo decennio. L’obiettivo è utilizzare come strumento per l’analisi del plasma una sonda d’eccezione: i quark pesanti, noti come “charm” e “beauty”. Hanno una massa così grande che possono essere prodotti solo nei primissimi momenti delle collisioni, quando sono più violente. Si può così disporre di un “tracciante”, che si muove nel plasma e si combina con altri quark per formare le particelle finali. Potremo quindi studiare direttamente la struttura dell’intero sistema. “Alice”, ma anche “Atlas” e “Cms” si preparano attraverso una serie di migliorie agli apparati sperimentali».
Il vostro obiettivo finale?
«Conoscere in modo dettagliato com’era davvero la struttura dell’Universo nella fase iniziale del Big Bang».
«Trovati sulla cometa i primi mattoni della vita»
Luigi Grassia
Il modulo Philae in questo momento è congelato in un crepaccio buio, su una remota cometa dal nome poco poetico (67P/Churyumov-Gerasimenko), in attesa che il corpo celeste, nella sua orbita, si avvicini alla luce e al calore del Sole e che questo risvegli anche Philae. Nel frattempo gli scienziati a Terra valutano la messe di dati scientifici che il modulo e la sonda Rosetta sono riusciti trasmettere. La novità più intrigante è la probabile scoperta di molecole organiche. I ricercatori vanno cauti, ma uno degli enti spaziali coinvolti nel progetto, cioè l’Agenzia spaziale tedesca, riferendosi ai dati preliminari di uno degli strumenti a bordo di Philae, ha fatto sapere che i primi mattoni della vita sarebbero stati rintracciati sulla cometa, anche se «l’identificazione e l’analisi delle molecole è ancora in corso».
L’identificazione di molecole organiche è una delle maggiori aspettative dalla missione Rosetta, perché si ritiene che le comete abbiano avuto un ruolo importante nella comparsa della vita sulla Terra : i componenti chimici delle future cellule si sarebbero formati nello spazio e sarebbero precipitati negli oceani primordiali usando le comete (nei passaggi periodici) come mezzi di trasporto. Le indiscrezioni dell’Agenzia spaziale tedesca sono autorevoli perché proprio alla Germania è stato affidato l’esperimento «Cosac», che consiste nell’«annusare» e analizzare i gas emessi dalla cometa.
Ma Philae regala anche altri risultati. Il suo braccio meccanico vibrante ha verificato che la cometa ha una superficie di 10-12 centimetri di polveri che ricoprono il ghiaccio. La temperatura del suolo è di 170° sotto zero. I sensori sismici, elettrici e acustici confermano che la cometa al momento non è attiva, ma, quando si avvicinerà al calore del Sole, ci si aspetta che si avviino movimenti delle rocce e del ghiaccio: la speranza è che gli strumenti del modulo si risveglino e possano documentare quel che succede
Ma Philae regala anche altri risultati. Il suo braccio meccanico vibrante ha verificato che la cometa ha una superficie di 10-12 centimetri di polveri che ricoprono il ghiaccio. La temperatura del suolo è di 170° sotto zero. I sensori sismici, elettrici e acustici confermano che la cometa al momento non è attiva, ma, quando si avvicinerà al calore del Sole, ci si aspetta che si avviino movimenti delle rocce e del ghiaccio: la speranza è che gli strumenti del modulo si risveglino e possano documentare quel che succede.