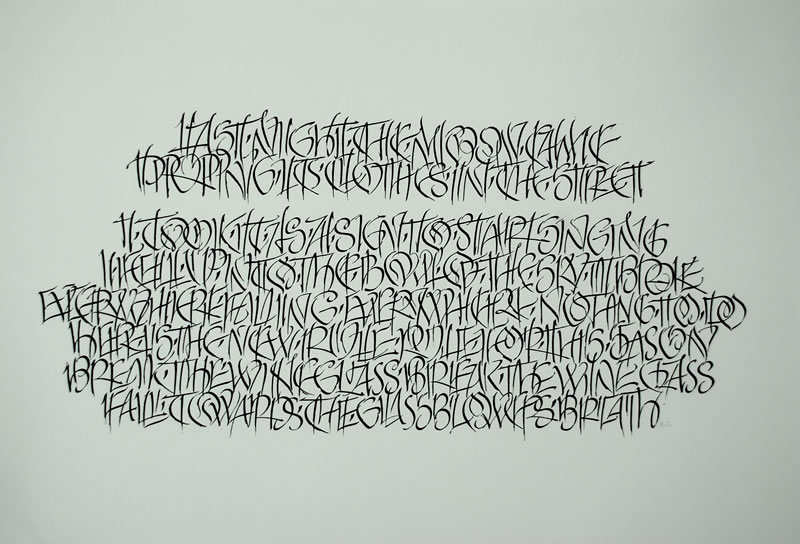La brevità per Nietzsche è il frutto di una cosa pensata a lungo,
per Orazio è il segreto della satira
Nicola Gardini narra la letteratura attraverso le rinunce che l'hanno resa grande
Nicola Gardini
"Il Sole 24 ore - Domenica", 28 settembre 2014
A Cisti fornaio basta una parola per far notare a messer Geri che sta approfittando della sua generosità (Decameron VI, 2). Quando il servo viene a chiedere altro del suo ottimo vino con un recipiente troppo capace, Cisti osserva che sicuramente messer Geri intendeva mandarlo da un'altra parte. Contenitori di quelle dimensioni, infatti, sono adatti a raccogliere l'acqua. «A Arno», dice semplicemente.
E quell'espressione lacunosa insegna a messer Geri tutto quello che occorreva sapere, e intanto induce noi al riso, che, come spiega Orazio satirico, vuole la brevità.
La lacuna espande il senso, portando la significazione oltre i limiti fisici delle parole scritte. Sartre chiama "silence" la produzione di senso. Il lettore, cioè, organizza gli stimoli dei segni grafici in un "più" che non è dato trovare in forma scritta, ma che è l'essenza stessa dello scrivere, l'inconfondibile qualità di un testo. «Senza dubbio l'autore lo guida; ma si limita a guidarlo; i punti di riferimento che ha posto sono separati dal vuoto, occorre congiungerli, occorre andare oltre».
Demetrio nel suo trattato Sullo stile, uno dei più significativi esempi antichi di teoria della lacunosità, dichiara che «un discorso è come un banchetto: pochi piatti possono esser sistemati in modo tale da sembrare molti» (cap. 62). Quasi due millenni dopo Nietzsche, principe dei lacunosi, in Umano, troppo umano riprende la metafora culinaria: «Una cosa detta con brevità può essere il frutto e il raccolto di molte cose pensate a lungo: ma il lettore che in questo campo è novizio e non ha ancora affatto riflettuto al riguardo, vede in tutto ciò che è detto con brevità qualcosa di embrionale, non senza un cenno di biasimo per l'autore, che gli ha messo in tavola per pranzo, col resto, simili cose non finite di crescere, non maturate».
Il testo è un organismo che trascende la sua propria apparenza o consistenza materiale. Il lettore interprete lo fa agire oltre i limiti della scrittura e, a sua volta, è attraversato dalla voce nascosta del testo. Cicerone, nel De oratore (II, 41), utilizza un'interessante metafora per spiegare il ruolo del lettore interprete: costui è un cercatore d'oro che va a scavare dove il testo gli indica. Bastano alcuni segni sul terreno, diligenza e riflessione e il prezioso metallo verrà estratto. L'interprete, dunque, entra nel mondo-miniera del testo, anzi, vi scende; e la discesa espande i confini dello spazio sensibile in cui ciascuno viveva prima della lettura.
Seneca offre un'altra espressiva metafora. Parlando delle forme dell'istruzione filosofica, distingue tra i grandi discorsi e la comunicazione più dimessa dei precetti (Lettere a Lucilio 38, 1-2). I precetti sono come semi, producono pensieri maggiori delle loro dimensioni (tutti ricorderanno che la similitudine del seme compare anche nei Vangeli, dove indica il destino di salvezza). Lo stesso Seneca loda Lucilio per la sua capacità di significare più di quanto dica.
L'espansione di cui parlano Cicerone e Seneca significa conoscenza (anche i Vangeli, in un certo senso, parlano di una forma di conoscenza, la fede); quello stesso tipo di conoscenza di cui tratta Aristotele nella Retorica: il comprendere e il concludere attraverso il ragionamento. Una conoscenza, si badi, che procura un piacere tutto particolare. Non è solo questione, infatti, di capire, ma anche di provare felicità per mezzo dell'intelligenza. Per questo la similitudine risulta meno piacevole della metafora: perché l'aggiunta del "come" allunga l'espressione e questo nega alla mente la possibilità di costruire il senso (Retorica III, 10, 3-4).
La lacunosità della formulazione, in definitiva, è preferibile, a livello sia stilistico sia argomentativo. Quel che si capisce subito non appaga. Molto meglio ciò il cui senso si compie con un qualche ritardo, perché solo così si arriva veramente ad apprendere.
Richiamandosi ad Aristotele, ancora Seneca afferma: «La ragione non si compie nell'ovvio; la sua parte più grande e più bella sta in quel che si nasconde…». E Demetrio, ripetendo un avvertimento di Teofrasto, che di Aristotele è stato discepolo, consiglia all'oratore di non fornire all'ascoltatore ogni dettaglio, bensì di omettere alcuni punti affinché quest'ultimo possa formarsi da sé un'idea della questione attraverso il ragionamento (cap. 222). Infatti, se ci arriva da solo, l'ascoltatore si dimostra meglio disposto verso chi parla. E perché? Perché – qui Demetrio si dimostra particolarmente acuto – si scopre intelligente grazie all'altro; il discorso dell'altro ha offerto alla sua intelligenza l'occasione di esprimersi. Pronunciare un discorso esaustivo è come trattare l'ascoltatore da stupido.
Arthur Schopenhauer, ha fatto della concisione e dell'essenzialità una sua bandiera, ponendole al servizio del vero. Leggiamo nei Parerga e paralipomena: «Bisogna far risparmiare al lettore tempo, sforzo e pazienza; con ciò si otterrà da lui la fiducia che quanto è stato scritto è degno di essere letto con attenzione e che la sua fatica sarà ricompensata». Schopenhauer arriva ad affermare che «è sempre meglio omettere qualcosa di buono che non aggiungere cose insignificanti». E cita la massima di Esiodo che «la metà è più dell'intero» (Opere e giorni, v. 40). Al lettore si devono dire solo cose che non potrebbe pensare da sé. Via fronzoli e orpelli: la verità sia tutt'uno con la cosa, libera e incorrotta dall'ampollosità, come in questa citazione di Giobbe, con la quale non potrebbe competere nessuna declamazione: Homo, natus de muliere, brevi vivit tempore, repletus multis miseriis, qui, tanquam flos, egreditur et conteritur, et fugit velut umbra (Gb 14, 1) («L'uomo, nato di donna, vive per poco tempo, pieno di molte miserie, che, come un fiore, spunta e avvizzisce, e fugge come ombra»). La conclusione: evitare il superfluo, le idee secondarie che depistano; «bisogna industriarsi per uno stile casto».
Anche William James, il fratello di Henry, si dimostra nemico giurato del secondario, ovvero – come lo chiama lui con formula originalissima – del «pensiero interstiziale» (interstitial thinking). Il pensatore e il conversatore eccellente – che James, ricorrendo a categorie sociali anziché a distinzioni puramente intellettuali, identifica con un membro dell'aristocrazia – evita di dire quello che non serve, abbrevia ed elide, usa una frase anziché venti o addirittura non parla proprio, a differenza dei plebei; e quando lo fa, fornisce solo i risultati, non l'accessorio. Ignorare, non degnarsi di prendere in considerazione, trascurare: questi i tratti del "gentleman". La mente volgare, invece, si perde nell'irrilevante.
Classismo a parte (a contraddire il quale basterebbe l'esempio di un Cisti), James suggerisce qualcosa di molto significativo: che l'«eliminazione del secondario» (suppression of the secondary) consente di volare più in alto (higher flights) e comunica una rassicurante idea di verità. Per quanto vero sia quel che possiamo udire dalla bocca di una persona comune, tendiamo a non crederle. Infatti, «le migliori idee sono soffocate, ostruite e contaminate dalla ridondanza delle loro più trite associazioni». Un uomo di mondo, invece, otterrà la nostra fiducia, quand'anche dovesse esprimere opinioni e gusti fasulli. Presumere di sapere di più di quel che si dice, in ogni caso, è segno di eccellenza.
L'intelligenza del lettore è tema cruciale nel saggio di Walter Pater Appreciations, uno dei saggi più belli che siano mai stati scritti sul lavoro degli scrittori.
Il grande oxoniense considera la pratica dell'esclusione – la ricerca dell'inessenziale, la riduzione della lingua all'immagine mentale, la rinuncia ai facili effetti eccetera – la fonte prima dell'arte letteraria. Il suo idolo è Flaubert e su Flaubert si conclude il saggio. Ricorre nel discorso la parola restraint (variata in self-restraint): controllo, contenimento, ascetica economia, frugalità. Il troppo, se anche dilettevole al momento, lascia nella memoria del lettore disturbanti onde. Il che rammollisce la forza dell'insieme. La disciplina del linguaggio darà tanta più soddisfazione al lettore, perché dalla disciplina lo stile uscirà tanto più esatto e lui proverà la gioia di assistere al trionfo dell'arte sulla difficoltà. Il piacere associato alla lacunosità di cui parla Pater è un'altra stupenda forma di partecipazione, il piacere di vedere il successo della creazione, anzi, del creatore. Potremmo addirittura chiamarlo, questo speciale piacere, "ammirazione" – un concetto che le varie teorie della letteratura, per non parlare dei lettori comuni, sembrano aver definitivamente smarrito, quelle maledicendo la soggettività e qualunque ombra di "genio", questi non dandosi alcun pensiero della fatica del costruire attraverso l'immaginazione. Nell'utilitarismo che domina ormai le riflessioni sulla letteratura, in qualunque ambito, l'ammirazione è inutile. Ma il lettore che ammira l'opera dello scrittore sarà il primo a esigere di più da se stesso, e vorrà migliorare anche la sua opera quotidiana, che consiste nel pensare e nel dare ordine e nome ai pensieri. Ognuno dovrebbe imparare, per quel che può, l'etica del self-restraint.