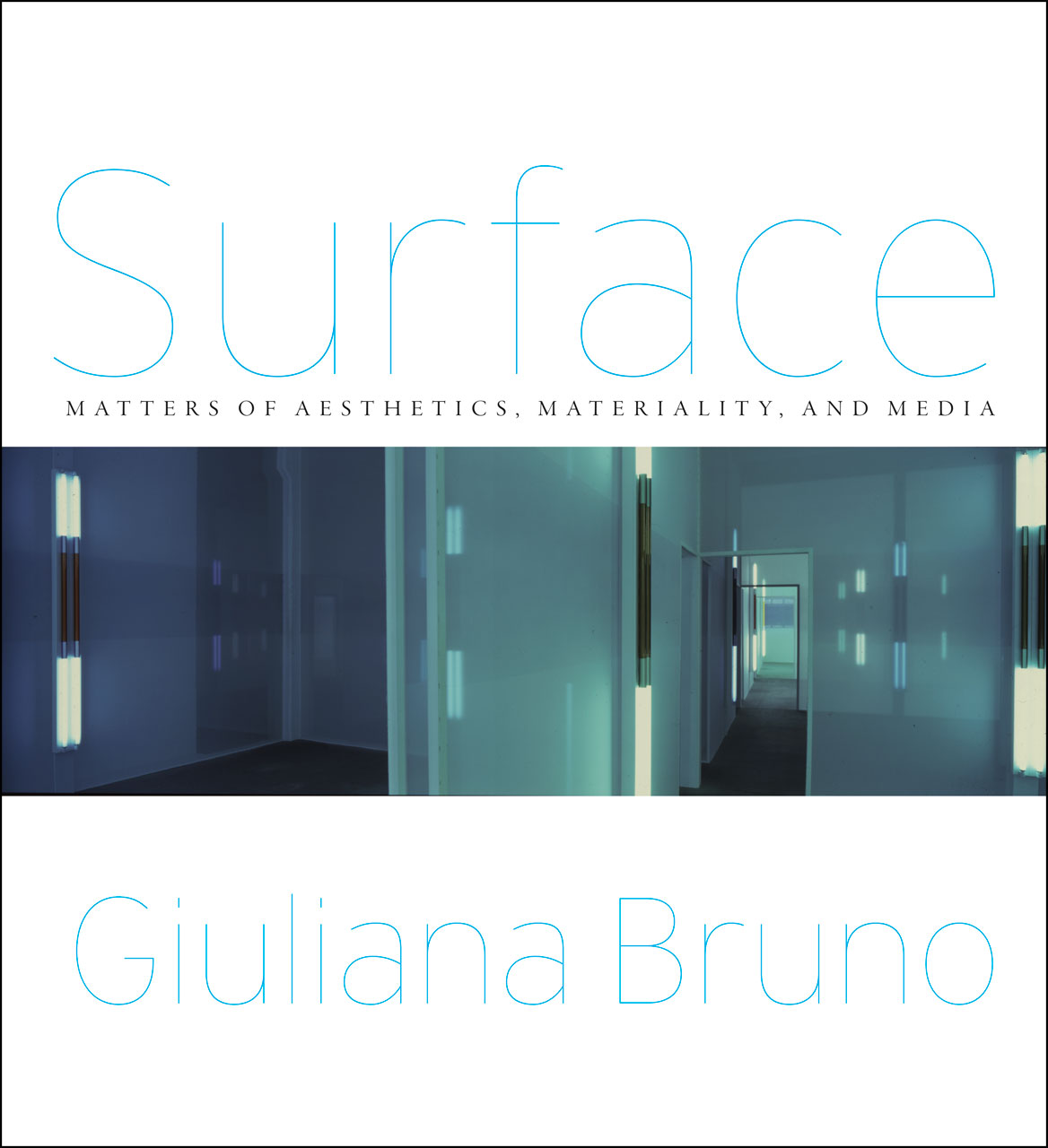"La Repubblica", 21 giugno 2015
Daria Galateria
ALCUNI DEI VERSI EROTICI per cui andò a processo per immoralità, Baudelaire li aveva presi direttamente dalla Bibbia. “Il ventre e i suoi seni, grappoli della mia vigna” (“ che i tuoi seni siano per me come grappoli della vigna”, Cantico dei Cantici, VII, 9). È la poesia I gioielli (l’amante, la splendida mulatta Jeanne Duval dalle reni “polite come olio”, si è lasciata addosso solo i gioielli tintinnanti: “ La très chére était nue, et, connaissant mon coeur , / Elle n’avait gardé que ses bijoux sonores ”). Ma le poesie che il pubblico ministero Pinard lesse nella requisitoria di un torrido 20 agosto 1857 restano ancora smaglianti, atroci e lesive (“Fare al tuo fianco attonito una ferita larga e profonda / e, vertiginosa dolcezza! Attraverso quelle nuove labbra… infonderti il mio veleno, o sorella!” (la “ferita” di quali nuove profonde labbra? E quale “veleno” — il seme, la sifilide?).
Lesse, Pinard, della «maschia Saffo, la amante e il poeta» che onora dei suoi pallori d’amore l’isola di Lesbo (dove i baci vanno “ gloussant” — Mérimée aveva appena appreso, in carcere, il verbo tecnico onomatopeico degli amori saffici, gnugnotter). Del resto nell’arringa il temibile Pinard — intimidito dalla scoperta che il poeta della bohème parigina si era rivelato figliastro di un senatore amico di Napoleone III — mostrò piena lucidità critica: l’imputato Baudelaire aveva sì scelto il partito della classicità, dei ritmi regolari, «monotoni»: e però alla fin fine «arriva alla testa, inebria i nervi; turba, dà le vertigini, e può anche uccidere». Il verdetto riconobbe l’impeccabile eleganza formale della raccolta, ma per il loro effetto «funesto» comminò al poeta un’ammenda, e la soppressione di sei poesie.
Sono stanco di essere considerato un lupo mannaro, scrisse a un amico Baudelaire. Girando per la città, raccoglieva, per farne poesia — come facevano nella notte i fraterni straccivendoli con i rifiuti delle metropoli da cui ancora si possa ricavare dell’oro — i diseredati del moderno, le vecchine “smembrate” che sono state donne, i ciechi che volgono al cielo, come una preghiera vuota, i globi incolori, gli operai che vanno a bere nelle bettole fuori città, dove il vino è meno caro. Il deluso del Progresso (la rivoluzione è turpe “come un trasloco”) traccia su un foglietto un ritratto di Blanqui, bello come un Satana. E, sul retro, appunta i versi di Longfellow e di Gray che citerà nel Guignon, “la scalogna”: e se il sonetto fosse un ritratto malinconico del grande utopista? E se — come voleva la sua fredda eleganza artificiale di dandy — considerava le donne naturali e perciò abominevoli, come mai cita Théroigne, la femminista rivoluzionaria? Nella vita, i suoi sentimenti andavano verso le piccole prostitute del Quartiere latino, come Sara l’Ebrea (“metteresti l’intero universo nel tuo letto”), o a povere attrici che non potevano disdegnare gli amori venali — anche se bastava uno sguardo, e una
Passante in gramaglie dal maestoso dolore poteva suggerire al poeta uno dei più bei versi dei piaceri irrealizzati: “Oh tu che avrei amato! Oh tu che lo sapevi.”

Les fleurs de Charles
“Meno bianco nei testi”, “Più aria in quella pagina”,
“Cambierei la dedica”, “Non sarebbe meglio togliere « poesie di...»?”
Escono in Francia, in una nuova edizione arricchita dai disegni di Rodin, le correzioni infinite che Baudelaire sottoponeva all’editore
prima che i suoi “Fiori del Male” vedessero finalmente la luce.
E che lui, per quei suoi versi scandalosi, finisse in tribunale
Anais Ginori
PARIGI SI SPAZIENTISCE ogni giorno di più l’editore Auguste Poulet-Malassis: «Mio caro Baudelaire, da due mesi stiamo rileggendo I fiori del Male e ne abbiamo stampato solo cinque pagine». Non può mandare in tipografia il fatidico volume fino a quando non riuscirà a sottrarne il manoscritto dalla mani del poeta. Che oltre a essere dandy, bohème e maledetto, è anche un maniaco della precisione, un perfezionista, correttore di se stesso a oltranza. Le bozze di stampa del 1857 sono un campo di battaglia. Note a margine, passaggi sbarrati, altri aggiunti, dubbi, intuizioni, commenti per l’editore e il tipografo. Baudelaire controlla tutto, non solo i suoi versi, ma anche la grafica, l’impaginazione, la grandezza dei caratteri. Il manoscritto originale de Les fleurs du Mal non è mai stato ritrovato. L’unica traccia che resta del continuo travaglio intellettuale di Baudelaire sono le bozze utilizzate dall’autore e dall’editore, pubblicate ora per la prima volta in Francia in un’edizione facsimile in tiratura limitata dalle Éditions des Saints Pères. Ogni pagina è stata restaurata, come in un quadro. Un oggetto preziosissimo, al quale sono stati aggiunti disegni inediti di Auguste Rodin. L’editore des Saints Pères si è specializzato nella pubblicazione di manoscritti originali. In poco più di un anno ha già stampato in tirature limitate La schiuma dei giorni di Boris Vian, Viaggio al termine della notte di Céline. Una piccola casa editrice creata da una ragazza, Jessica Nelson, appassionata di libri. Non di ebook, come tanti della sua generazione, ma di libri di carta, da toccare e ammirare nella migliore versione possibile.
Le bozze di stampa de I fiori del Male furono acquistate dalla Biblioteca nazionale di Francia nel 1998. Lo straordinario documento letterario venne messo all’asta da Drouot a Parigi e la Bnf esercitò il diritto di prelazione pagando la cifra colossale di 3,2 milioni di franchi (quasi cinquecentomila euro). Ne valeva la pena. Sfogliando la nuova edizione, pagina dopo pagina sembra di rivivere il tormento del poeta ad ogni riga. Prima di stampare il libro, il 25 giugno 1857, con l’editore Poulet-Malassis et de Broise, Baudelaire esercita un’attenzione ossessiva sulla rilettura, anche se il capolavoro dell’inventore dello Spleen e irriducibile flâneur è già pronto da tempo: la maggior parte delle poesie sono state scritte tra il 1841 e il 1850. È riuscito però con una certa fatica a far pubblicare le sue poesie su giornali e riviste, organizzando invece letture nei café parigini. L’incontro con Poulet-Malassis è dunque decisivo. Firmano insieme il contratto per Les Fleurs du Mal il 30 dicembre 1856 e il manoscritto viene consegnato subito, il 6 febbraio 1857. L’editore immagina di poter andare in stampa qualche settimana dopo. Ma si sbaglia. La rilettura dura più di quattro mesi. Come Balzac o Proust, Baudelaire corregge fino all’ultimo i suoi testi. Il poeta è attento non sono alla metrica, a ogni aggettivo, ma anche all’ortografia, alla punteggiatura, critica la grafica, chiedendo «più aria» o «meno bianco» nei testi.
Nonostante i continui richiami dell’editore, l’autore non è disposto ad accorciare i tempi. Si abbandona a ogni tipo di esitazione. Come sulla poesia Benedizione nella quale Baudelaire si domanda se è il caso di scrivere « blasphême », « Blasphême » o forse «blasphème ». Fa anche autocritica. Accanto a Spleen IV, annota il numero di pagine della raccolta: «245, pietoso, molto pietoso. E non c’è rimedio perché non mi preoccupo di scrivere nuovi versi e sonetti». Il lavoro di bozze è così puntiglioso e sofferto che Poulet- Malassis sembra quasi rassegnato. E confida agli amici: «I Fiori del Male usciranno quando vorrà Dio, e Baudelaire». Prima di dare finalmente il “Bon à tirer ”, il visto si stampi, il poeta aggiunge in extremis ancora qualche modifica. La dedica iniziale a Théophile Gautier viene cancellata: Baudelaire chiede a Gautier di fare da «padrino » ai suoi «fiori malaticci». Il poeta sceglie un più sobrio «Al mio amico e maestro». «Mi sembrerebbe meglio abbassare la dedica in modo da farla apparire a metà pagina » chiede però Baudelaire all’editore, anche se poi aggiunge: «Mi affido al suo gusto». Poi però imperversa ancora: «Sarebbe meglio mettere Fleurs in corsivo, o in stampatello corsivo» visto che si tratta, dice, di un « titre- calembour », ovvero un titolo che è anche gioco di parole.
Les Fleurs du Mal viene finalmente stampato ad Alençon, in Bassa Normandia, pubblicato il 25 giugno 1857. La raccolta dà scandalo. Il 5 luglio il critico del Figaro , Gustave Bourdin, parla di un’opera in cui «l’odioso s’accompagna all’ignobile» e «il repellente sporca l’infetto ». Due giorni dopo la procura di Parigi apre un fascicolo per “attentato alla morale pubblica, alla morale religiosa e al buon costume”. Gli stessi capi d’imputazione di Flaubert per Madame Bovary.
Per la seconda edizione, Baudelaire cambierà ancora l’architettura della raccolta, di cui solo lui ha il segreto: toglie le sei poesie bandite dai giudici ma ne aggiunge altre trentacinque. Poi sarà costretto all’esilio, in Belgio, e morirà pochi anni dopo con la consapevolezza di aver scritto un capolavoro. «Mi viene rifiutato tutto: lo spirito d’invenzione e persino della lingua francese» scriveva alla madre nel luglio 1857, durante il processo. «Mi faccio scherno di tutti questi imbecilli, e so che questo volume, con le sue qualità e i suoi difetti, farà il suo cammino nella memoria del pubblico letterato, accanto alle migliori poesie di Hugo, Gautier e persino di Byron».