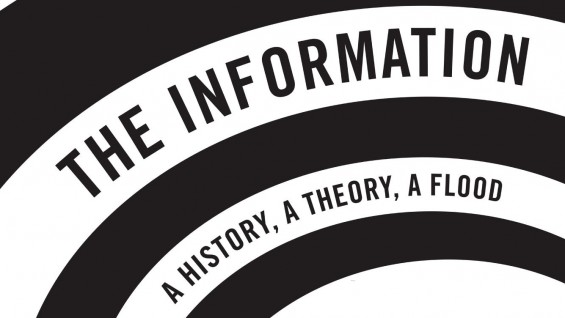Divulgare la scienza, in un mondo dominato dalla tecnica,
è uno dei temi culturali del futuro
Ian Tucker
"La Repubblica", 30 dicembre 2012
“Molte idee sono difficili anche per noi Per capirle facciamo domande idiote a persone intelligenti e le traduciamo per tutti” “Pochi accademici sanno comunicare l’essenza del loro pensiero. Per evitare l’esoterismo bisogna saper distillare gli elementi importanti”
Quali devono essere le qualità di un bravo divulgatore scientifico in un mondo dominato dalla tecnologia? Come si fa a spiegare cose complesse in modo semplice? Per saperlo abbiamo coinvolto, prima della cerimonia per l’assegnazione del Winton Prize, premio per il miglior libro scientifico dell’anno secondo la Royal Society di Londra, cinque dei sei finalisti: Steven Pinker, James Gleick, Brian Greene, Lone Frank e Joshua Foer, tra le maggiori autorità in questo campo.
Il tema è centrale, nella nostra società. Man mano che la scienza scopre sempre più cose sul nostro universo, le teorie e le scoperte diventano progressivamente più tecniche e infarcite di dati. Tanto più difficile e importante diventa quindi il compito di scienziati e divulgatori, che devono trasformare questo complesso lavoro in una prosa chiara e accessibile.
Perché è importante la divulgazione scientifica?
Joshua Foer:
Quando fu fondata la Royal Society, nel 1660, era ancora possibile per una persona istruita, un erudito, sapere qualcosa su tutti gli argomenti. Oggi non è possibile. Steven Pinker è un grande esperto di scienze cognitive, ma scommetto che non è in grado di spiegare come hanno scoperto il bosone di Higgs.
Brian Greene:
Me l’ha spiegato proprio poco fa e direi che se l’è cavata piuttosto bene.
JF:
Questo fa capire perché ci sia bisogno più che mai di persone brave a fare da interpreti. Quello che facciamo diventa sempre più importante perché la scienza diventa sempre più esoterica e servono persone che aiutino tutti a capirla.
Quando scrivete, qual è il livello di difficoltà che considerate accettabile per i vostri lettori?
Steven Pinker:
Prima di scrivere il mio primo libro di scienze cognitive una redattrice editoriale mi diede un consiglio. Mi disse che il problema che hanno molti scienziati e professori quando scrivono per il grande pubblico è che sono sussiegosi: danno per scontato che i lettori non siano troppo intelligenti, che il loro pubblico sia composto da camionisti, spennapolli e nonnine che lavorano a maglia, perciò scrivono come se si rivolgessero a un bambino piccolo, parlano con condiscendenza. Questa redattrice mi disse: «Devi partire dall’idea che i tuoi lettori sono intelligenti quanto te, curiosi quanto te, ma non sanno quello che sai tu e il tuo compito è dirgli quello che non sanno». Io sono favorevole a far fare un po’ di fatica al lettore, come io faccio la fatica di fornirgli tutto il materiale di cui ha bisogno per dare senso compiuto a un’idea.
Lone Frank:
Tantissimi ti dicono di non usare termini tecnici complicati, ma si può spiegare tutto alle persone se lo si fa scrivendo bene e usando parole semplici.
Vi è mai capitato di omettere qualcosa perché lo trovavate troppo difficile da spiegare?
BG:
Mai? Sempre. Sono d’accordo, in linea di principio, che tutto sia spiegabile, ma provate a spiegare le simmetrie nella geometria algebrica a un pubblico di non addetti ai lavori. Buona fortuna. Ci sono cose che sono davvero troppo difficili da comprendere se non si ha una formazione tecnica, ma l’abilità sta nel lasciare quel tanto che basta dell’essenza dell’argomento trattato da non svuotarlo del suo significato e rendergli giustizia.
JF:
Alla fin fine tutte le persone presenti in questa stanza per certi versi sono degli intrattenitori. Siamo in competizione con blog, videogiochi, film per catturare l’attenzione dei lettori. Io cerco di raccontare storie capaci di portare le persone dal posto A al posto B, non semplicemente nel senso di un tragitto narrativo, ma anche nel senso della comprensione dell’argomento. Farsi condurre in un viaggio del genere può rivelarsi straordinariamente gratificante.
James Gleick:
Non so se suonerà come una confessione o come una sbruffonata, ma spesso ci sono certi argomenti di cui scrivo che io stesso a stento riesco a capire. Scrivo libri su cose che mi interessano, racconto storie che considero importanti per la nostra cultura, e le cose scientifiche hanno sempre più peso.
L’informazione per certi versi non è un libro scientifico, ma scrivendolo ho dovuto barcamenarmi con cose parecchio tecniche. Perciò, per quanto mi riguarda, per capire queste cose spesso sono costretto a fare un sacco di domande idiote a persone intelligenti.
Nella mente della maggior parte delle persone, l’apprendimento è sinonimo di fatica. Vi capita di pensare che se non è difficile non è scienza?
SP:
Vi racconto un aneddoto che può far capire la differenza fra la mentalità dello scienziato e quella dello studioso di discipline umanistiche. Una volta andai a una conferenza a cui partecipavano scienziati e umanisti. Alla fine di una chiacchierata sull’analisi di un dipinto, l’oratore disse: «Bene, spero di aver reso più complicata la materia in oggetto sotto diversi aspetti». Mi venne da pensare che era questa la differenza fra uno scienziato e un critico, che lo scienziato avrebbe detto: «Spero di aver reso più semplice la materia in questione sotto diversi aspetti».
LF:
Tantissimi lettori di questi tempi si aspettano che tutto sia facile: non c’è nulla per cui siano disposti a faticare, e non accettano di leggere un libro se questo libro è appena un po’ difficile: lo buttano via e trovano qualcos’altro.
In questo momento sembra che ci sia un mini-boom dei libri scientifici. Cosa ne pensate?
BG:
Penso che ci siano sempre più persone desiderose di sapere veramente che cosa succede nel mondo della scienza.
SP:
Teniamo anche conto che noi persone istruite viviamo sempre di più in un mondo definito dalla scienza. La gente non crede che il mondo sia stato creato 5.000 anni fa, almeno non il tipo di persone che cerchiamo di convincere a comprare i nostri libri. Le persone istruite accettano il fatto che ci siamo evoluti dai primati, che la nostra vita mentale dipende dal funzionamento del nostro cervello, che siamo soggetti a illusioni, superstizioni e pregiudizi. Sono interrogativi esistenziali profondi, ed è la scienza a sollevare questi interrogativi e dar loro una risposta.
JG:
È chiaro che noi attribuiamo valore alla scienza, è chiaro che noi siamo consapevoli che è la scienza che spiega le domande a cui vogliamo assolutamente trovare una risposta. La cosa che più spaventa è che negli Stati Uniti (il Paese dove quattro di noi vivono) vediamo affermarsi la tendenza opposta: improvvisamente ho l’impressione che le persone siano sempre più ostili all’idea che sia la scienza quella a cui bisogna rivolgersi per trovare la risposta a queste domande.
SP:
Sì, probabilmente è vero che uno dei due grandi partiti politici in America si mostra fieramente ostile alla visione scientifica del mondo. Ma secondo me non è il modo migliore per vedere la faccenda, perché quando devono cercare un giacimento di petrolio queste persone fanno comunque affidamento sulle teorie sull’età della Terra che tutti consideriamo valide; quando si ammalano vanno dal dottore e si preoccupano dell’evoluzione della resistenza ai farmaci, proprio come facciamo noi. Non sono Amish, non è gente che ritorna a coltivare la terra. In un certo senso hanno già accettato il mondo della scienza, ci sono solo alcune questioni fortemente simboliche, che definiscono l’identità morale e politica di un individuo, su cui non sono disposti a discutere, e io penso che questo sia molto diverso dall’ignoranza scientifica. Uno studio fatto da un ex specializzando nel mio dipartimento, a Harvard, dimostrava che le persone che credono nella teoria dell’evoluzione non ne hanno una conoscenza migliore di quelle che la contestano. Non dobbiamo confondere la moralizzazione di un numero limitato di temi controversi con un’ostilità generale verso la visione scientifica del mondo.
La divulgazione utilizza spesso analogie. È meglio cavarsela con un’analogia comprensibile ma magari imperfetta o descrivere la faccenda nel dettaglio ma con il rischio di risultare incomprensibili?
SP:
L’analogia possiede una forza straordinaria. Si potrebbe dire che a parte il mondo fisico della caduta dei gravi la nostra comprensione delle cose passa sempre per l’analogia. Se guardate il linguaggio, in pratica è una metafora continua. Ma c’è una differenza fra la metafora letteraria e l’analogia scientifica, e sta nel fatto che in una metafora letteraria più collegamenti ci sono fra la figura retorica e la cosa concreta più la metafora è bella e ricca, mentre nell’analogia scientifica se ci sono troppi rimandi differenti al mondo reale vuol dire che è un’analogia infelice. Le analogie devono essere scelte e spiegate con cura. Bisogna mettere bene in evidenza al lettore, punto per punto, la corrispondenza fra la cosa concreta che si sta spiegando e l’analogia. Essere sballottati da un’analogia all’altra senza sapere quale è il punto, questo rende un’analogia fuorviante.
Ho letto da qualche parte che le analogie sono come soprabiti della misura sbagliata: le parti più importanti sono coperte, ma qualcosa può sporgere e intralciare il movimento.
JG:
Non sono d’accordo! Qualunque cosa può essere fatta male, ma sono anche convinto che l’analogia sia il modo in cui noi esseri umani impariamo ed esploriamo il nostro mondo. È vero, da un certo punto di vista, che un fisico vi dirà che il linguaggio della natura è la matematica, ma sono anche convinto che qualsiasi fisico, quando si crea la sua comprensione del mondo, pensa automaticamente mediante analogie. Qualunque modello scientifico o teorico è una sorta di analogia, il che è come dire che è imperfetto, fallace per definizione e come minimo incompleto. È un modello, non è il mondo in sé e per sé.
Gli autori scientifici sono reporter alle frontiere della conoscenza o dell’immaginazione?
LF:
Tantissime persone non si rendono conto che quello che fa la scienza influenza concretamente il loro modo di pensare. Pensano che la cultura nasca dalla filosofia, dalle opere teatrali e roba del genere, e che la scienza produca solo gadget. Io voglio cercare di far vedere come la conoscenza scientifica influenza la nostra cultura.
BG:
Penso che sia fondamentale che i bambini si rendano conto che la scienza implica la stessa creatività di qualunque altra disciplina definita creativa.
JG:
Penso che tutti noi che siamo seduti a questo tavolo non scriveremmo di scienza se condividessimo l’idea che il processo scientifico sia qualcosa di mnemonico e ripetitivo. Tutti e cinque abbiamo concentrato la nostra attenzione sull’immaginazione e la creatività, non solo come elementi occasionali accidentali del processo scientifico, ma come le cose che fanno funzionare questo processo, che lo rendono eccitante.
SP:
L’unico appunto che mi viene da fare a tutto questo è che nella scienza non basta essere immaginativi e creativi, bisogna anche dire cose esatte. Ci sono un mucchio di persone piene di immaginazione di cui la storia non ha conservato traccia, perché i loro bellissimi ed eleganti schemi non trovavano riscontro nella realtà.
Gli scienziati sono i peggiori nemici di se stessi quando si tratta di comunicare il proprio lavoro?
BG:
All’Università di Stony Brook c’è un nuovo istituto che nel programma di studi per gli specializzandi delle facoltà scientifiche prevede anche lezioni di comunicazione scientifica. A me sembra ragionevole pensare che se le persone riuscissero a comunicare meglio, anche tra scienziati e scienziati, più liberamente, in modo più chiaro, si metterebbero in moto più cose.
JF:
Quello che dovrebbe fare un libro o un articolo divulgativo è distillare, trovare gli elementi essenziali e comunicarli. Non è semplicemente un atto narrativo, è un atto del pensiero e richiede una chiarezza comunicativa da cui non solo gli scienziati, ma anche gli accademici in generale si sono allontanati: e il mio parere è che questo rende meno chiaro il loro pensiero.
(Traduzione di Fabio Galimberti) © /Guardian News & Media Ltd