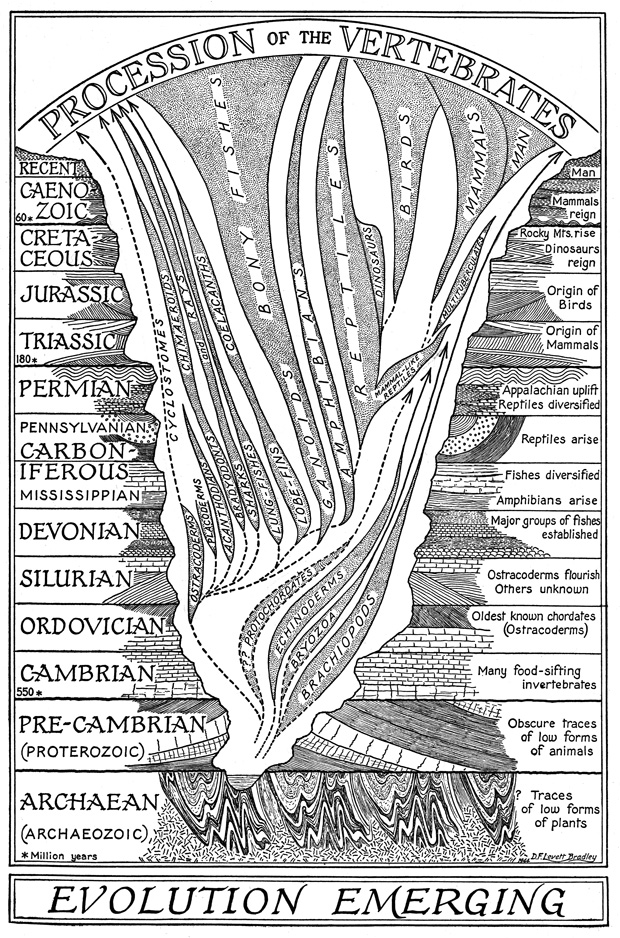Poeta, docente universitario saggista e scrittore, è uno dei più grandi latinisti italiani
“La storia insegna che il mondo è un incubo senza risveglio”
“I miei stessi idoli erano canaglie. Cesare? un criminale di guerra”
“Dagli studi alla famiglia, ho barato in tutto e la mia figlia segreta non sa che sono suo padre”
intervista di Antonio Gnoli
“La Repubblica”, 29 settembre 2013
Ad ascoltare Luca Canali, illustre latinista e scrittore, mentre narra la sua vita, sembra di piombare nel Grande Romanzo dell’Infelicità: «Non amo la solitudine, non l’ho scelta. Essa mi pesa enormemente. Eppure è qui, accanto a me, esigente nel rivendicare ogni volta il suo diritto. Faccio fatica a capire il senso di qualcosa che negli anni è diventata una prigione». Canali ha quasi 90 anni. Vado a trovarlo nel piccolo e modesto appartamento romano, pensando all’uomo la cui vita è stata illuminata dai lampi dell’antichità e da una remota militanza politica. Strane mescolanze in un’esistenza segnata da malattie dell’anima e da insidiosi pensieri: «Non ho mai voluto essere il migliore, e se qualche volta ciò è accaduto, la mia mente mi obbligava a pensare di essere nessuno». Epica di autolesionista, penso. Ma se scavo nel suo volto, ancora bello e grifagno, colgo una beffarda infelicità, e vi leggo il benvenuto ai piccoli inferni quotidiani.
Vive sempre così appartato?
«Ahimè, non sono quel che si dice un tipo mondano. Però non deve pensare che sia sempre stato così. Soprattutto da bambino avevo parecchi amichetti. Mia madre mi portava al Pincio, oppure sciamavo sotto casa. La mia è stata un’educazione stradaiola».
Chi erano i suoi?
«Mio padre faceva il carbonaio, mia madre era una maestrina. Lei si innamorò di quest’uomo strano, un donnaiolo impenitente. Soffrì di gelosia, come io avrei sofferto per tutto il resto. Abitavamo a Roma in via Gesù e Maria, una traversa di via del Babuino. Proprio davanti casa c’era un postribolo. Un altro era in via Laurina, uno in via della Fontanella, e uno in via Panisperna».
Anche quella fu un’educazione?
«Li ho frequentati, a volte ci andavo senza una necessità precisa. Per fiutare l’ambiente, perdendomi in certe sensazioni. Erano luoghi di interclassismo patetico e di superflue perversioni. Frequentato da vecchi renitenti alla leva del tempo che passa. Di non rassegnati. Ma anche luoghi creativi. Un grande latinista, Antonio La Penna, mi diceva: Luca, a me le migliori idee sono venute al casino».
Anche lei è un grande latinista.
«La ringrazio per il grande. La mia carriera di studioso fu frammentaria,incerta, pericolosa».
Andiamo con ordine. Dove ha studiato?
«Mia madre, ambiziosetta, mi mandò prima dalle suore inglesi e poi al Visconti: otto anni tra ginnasio e liceo. Frequentato da gente chic. Ero il solo a evidenziare un certo complesso di inferiorità. Vestivo male, portavo i maglioni dismessi da mio padre. Devo dire che i compagni di classe non avevano atteggiamenti di superiorità, erano i professori a discriminarmi un po’».
E lei subiva?
«Cercavo il riscatto negli studi. Mi mostrai bravo in latino e greco. Un professore di storia dell’arte, che sarebbe morto combattendo contro i tedeschi sotto le mura di San Paolo, ci aprì la testa leggendoci I fiori del male di Baudelaire eLe elegie duinesidi Rilke. Cominciai così ad amare la letteratura. A 16 anni scrissi le mie prime poesie che Ungaretti, con mia sorpresa, pubblicò sullaFiera letteraria.A giugno, quando finiva la scuola, con i compagni andavamo a fare il bagno al Tevere. Non dal “Ciriola”, dove spesso c’era Pasolini, ma da Ercole Tugli. Ci capitava di incontrare spesso Sandro Penna, del quale divenni amico».
Che ricordo ne ha?
«Un conversatore lamentoso ma non privo di fascino. Era come se la vita ogni volta gli morisse sulle labbra. Ricordo il suo incedere lento. Veniva giù da Ponte Vittorio, non lontano dal vicolo dove abitava, a braccetto della madre. Un gay d’altri tempi. Con i miei amici di scuola cominciammo a occuparci di politica. Scoprii l’esistenza del Partito Comunista. Si avvicinava la fine della guerra. Riparai in montagna per sfuggire alla ferma milita-re e infine mi iscrissi al partito.
Quanto è rimasto nel Pci?
«Sono stato nel partito dal 1945 al 1958. Ho diretto cinque sezioni romane, l’ultima in borgata. Il segretario della federazione, Otello Nannuzzi che aveva preso il posto di Aldo Natoli, mi disse: Luca, hai diretto solo sezioni borghesi, ti manca la classe operaia. E andai al Prenestino, dove rimasi un paio d’anni. Non ho mai pensato di fare una vera carriera politica, per mancanza di vocazione al compromesso. Poi nel 1958 – c’erano già stati i fatti di Ungheria – fui radiato dal partito. Buttarono fuori anche Tommaso Chiaretti, Mario Socrate, Dario Puccini e tra i pittori: Vespignani e Attardi. Venimmo accusati di revisionismo senza principi. Io nel frattempo mi ero iscritto all’università. E alla fine mi laureai con una tesi su Lucrezio».
Con chi?
«Con il terribile Ettore Paratore. Mi diede 110. Commentò, in seguito, che non poteva dare la lode a un comunista. Divenni suo assistente».
Era un uomo difficile. Un conservatore a oltranza, come poteva conviverci?
«Mi stimava. Era famoso perché bocciava a ripetizione. Ma era un genio, coltissimo. Aveva solo un debole: scriveva romanzi orrendi. Tanto che i figli, credo, sono stati costretti a farli sparire dalla circolazione. Nel frattempo mi riavvicinai al partito. Mario Alicata, che si occupava tra le altre cose anche de
dopo avermi cacciato, mi riprese come redattore. Ma quando morì, il suo posto di responsabile della cultura fu assunto da Rossana Rossanda».
Andai da lei e le dissi: scusa, ma lì io avevo il solo stipendiuccio, e per campare non ho altre entrate. E lei: hai l’università. E io: ma non prendo una lira. E lei: non ti preoccupare, vedrai che farai strada. E io, la guardai rassegnato».
«Mica fu semplice. Comunque divenni professore di ruolo e fui chiamato a insegnare a Pisa. Ho insegnato per 15 anni. Mi piaceva. Furono anni splendidi e durissimi. Ma alla fine non resistetti. E lasciai l’università».
«Ero doppiamente malato. Fui investito da una profonda depressione, che quando è seria ti viene voglia di ammazzarti; e l’altra malattia, fastidiosissima e fortemente condizionante, fu una psiconevrosi fobico ossessiva».
Come si manifestavano le sue ossessioni e fobie?
«Nel fatto, ad esempio, che le cose dovevano essere disposte in un certo modo. Ero capace di tornare improvvisamente a casa se solo fossi stato sfiorato dal dubbio che un certo oggetto era in un posto diverso da dove io lo immaginavo. O se avevo la sensazione di essermi dimenticato qualcosa che volevo ricordare, potevo restarne ossessionato per giorni. Perfino i nomi delle persone costituivano un problema. Se dimenticavo un nome, mi accadeva di passare nottate su un elenco telefonico per vedere se casualmente riaffiorasse. Tutto poteva trasformarsi in una ossessione».
Depressione e fobie però le ha superate.
«In forma blanda ancora ci sono».
Come le ha curate?
«Per anni, in un paesaggio di flebo e di lenzuola, mi sono imbottito di farmaci. E sono stato diverse volte in cliniche psichiatriche tentando di curarmi. Dalla depressione si può uscire; con le psiconevrosi è più difficile».
Si ricorre alla psicoanalisi.
«Ho fatto centinaia di sedute analitiche. Inutili. Da un punto di vista psicofisico il periodo migliore furono gli anni dell’impegno nel partito. Ero guarito. Forse perché ci credevo davvero.Forse perché io, che non ho mai avuto una fede, lì, avevo una fede. Poi, quando seppi dei crimini staliniani mi cascò il mondo addosso».
Perché dice che quelle malattie ancora non l’hanno abbandonata del tutto?
«Perché ancora oggi mi sdraio sul letto, chiudo gli occhi, e desidero non risvegliarmi più. E il risveglio è orrendo. Ancora oggi ho l’ossessione che non mi fa uscire da Roma. Sono decenni che non faccio una villeggiatura».
Si è dato una spiegazione?
«Non c’è spiegazione».
Non c’entra forse quel mondo antico che ha studiato?
«Non lo so. Francamente adoro la storia romana».
Cosa le ha insegnato?
«Che la storia è realismo e brutalità. Come diceva Stephen Dedalus: la storia è un incubo dal quale cerco inutilmente di svegliarmi. È un continuo scorrere di sangue, un moltiplicarsi di guerre e di morti. I miei stessi idoli erano delle canaglie. Cesare? Un criminale di guerra. Augusto? Grande politico, pessimo combattente le cui imprese descritte sono per metà false».
Lei ha anche scritto un Satyricon e collaborato con Fellini.
«Fu un’esperienza straordinaria vederlo dirigere il film. Il mio rapporto con lui fu propiziato da Antonello Trombadori. Fellini gli chiese se conosceva un latinista – senza il basco in testa, precisò ironico – che lo potesse aiutare non tanto a dirgli cosa fare, quanto cosa non fare. Aveva delle battute meravigliose. E diventammo amici. Per come si poteva intendere l’amicizia con lui. Qualcosa di volatile».
Lei ha scritto tantissimo.
«Sì, per anni ha fatto parte della mia terapia».
Citava Joyce, le piace?
«Lo preferisco a tutti gli altri scrittori del Novecento. Ulisse è il romanzo del buon umore. Mi attrae proprio per la sua natura così lontana dalla mia. E poi gronda sensualità: bassa, terrestre, vitale e avvolgente come una cappa di umidità».
Torniamo al sesso.
«Cosa vuole sapere?».
Dica lei.
«Con le donne sono stato spesso arrembante. E ho avuto molta fortuna. Ero un intellettuale colto e bello. Piacevo. Sono stato sessualmente molto attivo, ma senza nessun coinvolgimento. Ed era chiaramente il sintomo di una nevrosi».
Ci spieghi.
«Diciamo pure un problema sessuale. Quando mi innamoravo di una donna e subentravano gli affetti, non riuscivo più a fare l’amore fisico. Mi sembrava di commettere un incesto, perché quella donna diventava per me una sorella. Può immaginare cosa sia stato il mio matrimonio».
È sposato?
«Mia moglie è morta da parecchi anni. Fu un errore sposarmi. Non ero adatto. Ha molto sofferto. Mi sono occupato di quell’opera colossale che fu l’impero romano e la sua caduta e non vedevo che la decadenza era in casa».
Ha figli?
«Una figlia, ormai grande e...».
E...
«Una figlia segreta, con la quale parlai una sola volta, nascondendole il fatto che ero il padre».
Lo dice con un senso di rimpianto.
«Per molto tempo questa storia mi ha fatto soffrire. La madre – una donna importante, con due matrimoni alle spalle – mi impedì di vederla. Poi i medici mi consigliarono che era meglio così e mi rassegnai».
In fondo, non è stato un uomo fortunato.
«Qualche fortuna grande, e molte sfortune. Le malattie sono state un grosso impedimento. Ogni tanto ripenso ai continui litigi tra i miei genitori. Mia madre disprezzava mio padre e lui se ne fregava. Credo di non avere mai avuto una vera famiglia».
L’ha condizionata?
«Non ne sono proprio sicuro. Forse ho perfino vissuto più liberamentela mia vita».
Come si vede nell’imminenza dei 90 anni?
«Sono contento di me ma non della mia vita. La mia mente continua a funzionare anche quando non vorrebbe. Anche quando vorrei che tutto tacesse. A volte mi penso morto e immagino il mio corpo che si decompone. E l’angoscia riemerge. No, non sono stato decisamente fortunato. Nel gioco non ho avuto belle carte».
Lei ha scritto, ora ripubblicato, quello che in molti ritengono il suo libro più bello:Autobiografia di un baro. Perché “baro”?
«Fa parte della psicologia insana. Spesso ho la sensazione di barare. Perché i miei strumenti intellettuali, le mie parole coprono un’infelicità, un dolore, un fallimento. Ho barato in politica perché dopotutto non me ne fregava più di tanto; ho barato in famiglia, come può fare un marito inadatto; ho barato all’università non riuscendo a dare ciò che avrei potuto, o nascondendo i miei limiti. Solo come infermo mi pare di avere agito senza trucchi».