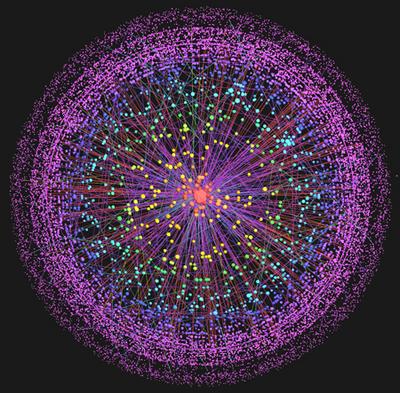Maurizio Ferraris
"La Repubblica", 24 luglio 2014
In La musa impara a scrivere (1986) Eric Havelock aveva analizzato, con lo sguardo del filologo classico, i cambiamenti epocali comportati dal passaggio dall’oralità alla scrittura: trasformazioni nei fruitori (che non avevano più bisogno di ricordare a memoria i propri testi preferiti) e nei produttori, che dovevano immaginarsi un pubblico insieme più distratto (si può leggere senza troppa attenzione, si possono saltare le pagine più noiose) e più severo (il lettore potrà tornare sul testo, e criticarlo). Pochissimi anni dopo l’uscita di quel libro, ci si è trovati di fronte a una svolta non meno radicale.
Caratterizzata dall’esplosione e diffusione capillare della scrittura (e delle registrazioni in generale) nel web. È la cosiddetta “quarta rivoluzione” — dopo il passaggio dalla oralità alla scrittura, poi dal rotolo al volume, e infine dai manoscritti alla stampa — che dà il titolo sia a un illuminante libro di Gino Roncaglia (La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del libro Laterza 2010), sia, recentissimamente, a un libro di Luciano Floridi, The Fourth Revolution. How the Infosphere is Reshaping Human Reality (Oxford University Press 2014).
In brevissimo tempo i nostri computer, tablet e smartphone hanno avuto accesso alla più grande biblioteca di tutti i tempi. Se nel passaggio dall’oralità alla scrittura il fruitore era diventato necessariamente un lettore colto, cioè alfabetizzato, nel passaggio dalla scrittura su carta al digitale il fruitore è diventato un potenziale autore. E un autore esigente, che se si annoia può aprire tutti i libri che vuole, visto che ovunque sia nella realtà fisica, in quella web dispone di una biblioteca sconfinata.
Non è vero, dunque, come sosteneva un po’ catastroficamente Nicholas Carr in Internet ci rende stupidi? (Raffaello Cortina 2011) che il passaggio al digitale è fonte di degrado culturale, anzi, un [sic] costituisce potenziale pericolo per l’intelligenza (era del resto la stessa obiezione di Platone contro la scrittura, e il capovolgimento della tesi, decisamente troppo ottimistica, di Pierre Lévy in L’intelligenza collettiva, Feltrinelli 1996). Anche se è certo vero, come ha sostenuto Roberto Casati in Contro il colonialismo digitale (Laterza 2013) che è la lettura cartacea è concepita come un momento di concentrazione, mentre quella digitale ha luogo su un supporto in cui convergono mille altre sollecitazioni. Nessuno, mentre leggiamo un libro cartaceo, ci chiede di rispondere a una lettera, mentre quando leggiamo sul nostro tablet avviene in continuazione.
Questa trasformazione della lettura (e correlativamente della scrittura) è al centro di un articolo di Maria Konnikova sul New Yorker. La lettura online è diversa da quella su carta e la letteratura non può non fare i conti con questa circostanza. Se leggendo silenziosamente l’ Iliade su carta è bene presupporre che era un’opera originariamente orale e comunque destinata a una lettura ad alta voce, leggendo la Recherche su Kindle è bene non dimenticare che si tratta di un testo uscito in sette volumi tra il 1909 e il 1922. E chi oggi si mette a scrivere un romanzo deve essere consapevole del fatto che potrebbe essere letto in un modo molto diverso da come erano letti i romanzi tradizionali. Ad esempio, dati sperimentali citati dalla Konnikova dimostrano che leggere un romanzo su Kindle rende molto meno attenti alla trama, che dunque dovrà essere o semplificata, o resa meno rilevante rispetto ad altri effetti di scrittura.
Proprio la consapevolezza della centralità del medium nella produzione e nella ricezione delle forme narrative sta al centro anche del convegno dello Igel (International Society for the Empirical Study of Literature and Media) che si tiene in questi giorni all’Università di Torino (il programma e l’abstract delle relazioni si può trovare a questo indirizzo: http:// www.igel2014.unito.it/). Richiamandosi a Bourdieu, il principale organizzatore del convegno, Aldo Nemesio, ha osservato che quei filosofi e studiosi di letteratura che insistono nel considerarla come una forma espressiva ineffabile si rendono giustizia da soli (perché se è inesplicabile non c’è bisogno di loro), e soprattutto non tengono conto del fatto che, invece, moltissime caratteristiche del fatto letterario si possono spiegare proprio a partire dal medium di cui si serve. Insomma, come la comparsa della fotografia ha decretato la fine del realismo pittorico, così la comparsa di wikipedia e ha generato una letteratura tendenzialmente più precisa e prolissa (non ci vuol niente ad accumulare dettagli e informazioni).
Queste trasformazioni, ovviamente, non riguardano solo la produzione e fruizione di testi letterari. Andare in biblioteca ormai non risponde più, in molti casi, all’esigenza di accumulare informazione ma, semmai, alla speranza di trovare un luogo in cui si possa stare tranquilli. Una speranza che, del resto, il più delle volte è illusoria, visto che oggi in biblioteca ci si va con il computer e le biblioteche sono generalmente ben connesse.
I libri restano sugli scaffali, e buona parte della lettura avviene online, il che, di nuovo, non è la stessa cosa. A parità di contenuto, la lettura digitale è più veloce, perché sfogliare le pagine è una operazione che richiede più tempo che far scorrere verticalmente lo schermo, e soprattutto più faticosa, non tanto per le caratteristiche dello schermo, quanto piuttosto per il continuo navigare fra link che è ormai tipico della lettura digitale.
Questo procedimento si trasforma nella creazione di un nuovo testo: c’è chi leggendo una pagina web aprirà certi link, e chi ne aprirà degli altri. Alla fine del processo, di lettura cursoria e insieme di continuo ampliamento del campo, i due avranno letto, di fatto, due testi diversi. Con un’impresa che nel peggiore dei casi potrebbe ondeggiare tra l’apprendistato di Bouvard e Pécuchet e quello di Rousseau, tra la volontà di sapere ottusa e pedante e la disperazione nervosa, come quando Jean-Jacques scopre che a pagina 3 di un libro si trova un passo oscuro, cerca di chiarirlo con un altro libro, che risulta però indecifrabile a pagina 2, rinviando a un terzo libro, che a pagina 4 contiene un enigma, e alla fine si trova sconfortato in una stanza piena di libri aperti.
Ma la rivoluzione in atto nelle modalità di lettura ha conseguenze forti anche sull’apprendimento. Come testimonia la scienziata americana Maryanne Wolfe, la specialista delle tematiche cognitive e linguistiche citata nell’articolo del New Yorker: dalle centinaia di segnalazioni che le giungono da insegnanti e docenti universitari, si ricava che gli studenti che si formano solo su computer, tablet, Kindle e dispositivi analoghi hanno attitudini diverse. A volte lacunose. Architetti che giunti sul luogo fisico su cui agire sembrano non orientarsi. O specializzandi in neurochirurgia con una tendenza eccessiva al copia e incolla mentale. O ancora i tanti liceali incapaci di apprezzare i classici della letteratura. Di fronte a queste sfide, e a questi problemi aperti, la questione non è tanto demonizzare le novità. Quanto imparare a essere lettori (e scrittori) digitali migliori.