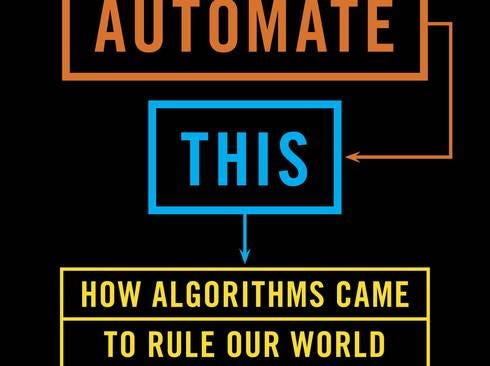Julien Bisson, André Clavel, Philippe Delaroche et Alexandre Fillon
La littérature allemande, ce n'est pas seulement Goethe et Schiller.
12 écrivains allemands contemporains à découvrir.
Mais quels sont ceux qui, dans les dernières décennies, ont pris la relève ? Et quels sont les nouveaux mousquetaires de la jeune garde ? C'est à ces questions que répond Lire avec ce panorama des auteurs qui, de Bernhard Schlink à Juli Zeh, se frottent presque tous à l'histoire de leur pays. Pour s'attaquer à des problèmes de société, poser la question de l'identité de l'Allemagne, interroger son passé douloureux et faire le bilan spirituel et émotionnel d'une réunification qui continue à les hanter.
Ferdinand von Schirach
Né en 1964,
Ferdinand von Schirach a passé sa jeunesse à Munich et a fait ses études chez les jésuites avant de devenir avocat au barreau de Berlin, spécialiste réputé du droit criminel. Un métier dont il s'est inspiré pour publier en 2009 un recueil de nouvelles basées sur des cas tirés des archives judiciaires : les très médiatisés
Crimes, qui trônèrent pendant cinquante-quatre semaines en tête du palmarès du Spiegel. Au générique, onze affaires criminelles où le monstrueux fait soudain irruption dans le quotidien, tandis que von Schirach abandonne le registre du pur témoignage pour transformer son matériau en littérature : d'un récit à l'autre, il ne cesse de maquiller la réalité et de brouiller les pistes, tout en explorant avec un doigté d'analyste l'inconscient des criminels et la passion destructrice qui les a aveuglés.
Ce qui frappe, sous la plume de l'avocat, c'est sa manière de décrire le sordide avec une prose totalement épurée, dénuée de tout effet de manche et de tout pathos, comme si l'assassinat devenait l'un de ces "beaux-arts" chers à Thomas De Quincey : les histoires de von Schirach sont autant de machines infernales qui, au-delà des affaires individuelles, dévoilent la violence larvée d'une Allemagne encore traumatisée par son passé, et incapable de panser les plaies de la réunification.
Gallimard vient de publier Coupables,un second recueil de nouvelles où, une fois de plus, le monde de la justice est confronté à des destins saccagés. Pourquoi des êtres ordinaires peuvent-ils soudain basculer dans l'innommable ? Comment préserver une part d'humanité, malgré tout, lorsque l'inhumain fait irruption dans la vie du prévenu ? Et comment la machine judiciaire transforme-t-elle les êtres au moment où leur intimité devient affaire publique, sous le feu des médias ? A ces questions, von Schirach répond plus en moraliste qu'en pénaliste, ce qui explique sans doute son succès dans une Allemagne où ses livres dépassent le million d'exemplaires.
Dernier livre paru : Coupables (Gallimard)
A.C.
Judith Hermann
Il lui a suffi d'un livre pour marquer la littérature allemande contemporaine. En 1998, Sommerhaus, später connaissait un succès phénoménal outre-Rhin et récoltait plusieurs prix littéraires. Quelque chose de comparable à ce qu'a pu être Anna Gavalda en France, bien que leurs univers soient fort différents. Avec les neuf nouvelles de
Maison d'été, plus tard(Albin Michel, 2001), vendues à plus de 200 000 exemplaires en Allemagne et traduites dans une vingtaine de pays, la jeune Berlinoise née en 1970 imposait une voix singulière et douce-amère. Tout en subtilité, portée par une prose à la maîtrise et à la beauté étonnantes. Une prose sondant notre rapport au monde et la difficulté d'avancer dans l'existence.
Depuis,
Judith Hermann prend le temps de peaufiner ses livres. Elle en a signé trois en quatorze ans. Après Maison d'été, plus tard, il y eut Rien que des fantômes (Albin Michel, 2005), recueil de sept nouvelles ciselées dépeignant des personnages en suspens et leur questionnement intime. Puis vint
Alice, sorti en France en début d'année, son plus beau livre à ce jour, couronné par le prestigieux prix Hölderlin. Il s'agit cette fois d'un roman composé de cinq nouvelles mettant en scène une femme à différentes étapes de sa vie. L'héroïne de Judith Hermann se prénomme Alice. Un hommage avoué à la grande nouvelliste canadienne Alice Munro, l'une de ses influences majeures.
Née à Berlin un mois d'avril, Alice a une quarantaine d'années quand on la découvre. La voici d'abord face à un ancien amour. Un homme qui s'est marié après leur séparation, a eu un enfant et s'éteint lentement d'un cancer. Eblouissant d'un bout à l'autre, Alice est de ces romans que l'on sait qu'on va relire, que l'on a envie d'offrir autour de soi. Judith Hermann s'y montre un admirable peintre des sensations et des lumières.
Elle arrive à faire ressentir le temps suspendu au-dessus d'êtres pris dans la tourmente, le quotidien qui continue malgré tout. Son sujet est l'un des plus essentiels et ardus qui soient. Quel est notre rapport à la mort ? s'interroge-t-elle. La mort que l'on prend de plein fouet, celle qui ne cesse de nous obséder, celle dont on est le témoin plus ou moins passif. L'écrivaine creuse l'absence, les souvenirs et l'attente avec un saisissant mélange de force et de beauté.
Dominique Autrand, son éditrice et traductrice chez Albin Michel, parle d'elle mieux que quiconque. Et évoque "une personne rare, d'une grande qualité d'âme". Une femme "chaleureuse et attachante. Elégante. Fine, d'une sensibilité extrême, pudique, discrète, modeste", pleine d'humour aussi. Selon elle, Judith Hermann a besoin d'une longue maturation avant de se mettre à sa table de travail, après quoi la phase d'écriture à proprement parler est relativement courte. Son prochain livre est en cours. On sait juste qu'il devrait s'agir encore de nouvelles. Qui s'en plaindra ?
Dernier livre paru : Alice (Albin Michel)
Alexandre Fillon
Bernhard Schlink
A Berlin,
Bernhard Schlink, né en 1944, est un juge réputé. Mais ce magistrat est aussi un brillant romancier, ce qui lui permet de jouer tous les rôles - aussi bien celui du coupable que celui de la victime - sans être jamais contraint de livrer un verdict puisque la littérature a horreur des jugements irréversibles. Dans ce domaine, Schlink a prouvé qu'il avait pas mal d'atouts, grâce à une oeuvre très intimiste qui ne cesse d'ausculter les blessures de son pays natal.
Après un tour de piste du côté du polar, il a connu un succès phénoménal en 1995 - des centaines de milliers d'exemplaires à travers le monde - avec un roman magistral,
Le Liseur, où il évoque l'inexpiable culpabilité de sa génération. Celle qui a grandi sur les décombres de la guerre avec, pour seul héritage, la monstruosité des crimes nazis. Et dans la foulée de ce livre emblématique, l'écrivain-juriste a signé un recueil de nouvelles - Amours en fuite - où il met en scène une Allemagne qui, malgré la chute du Mur, ne réussit toujours pas à digérer son passé : les personnages de ces récits sont des prisonniers des ombres, à cause de tous ces fantômes - ex-complices de Hitler, repentis de la dernière heure, anciens corbeaux de la Stasi - qui les empêchent de regarder vers l'avenir.
C'est donc dans la chair de son pays que Schlink puise son matériau, et dans l'inconscient collectif de ses compatriotes. Une quête à la fois politique et psychologique que l'on retrouve dans Le Week-End, où il évoque les années noires de l'Allemagne : celles de la fureur terroriste qui transforma de jeunes idéalistes en assassins aveugles tout au long de la décennie Rudi Dutschke, une dérive tragique dont Schlink dresse un bilan sans concessions mais jamais manichéen. A lire, également, Mensonges d'été, un recueil de brefs récits où, cette fois, le Berlinois conjugue l'amour sous toutes ses formes, comme si son oeuvre s'ouvrait à une nouvelle quiétude.
Dernier livre paru : Mensonges d'été (Gallimard)
A.C.
Daniel Kehlmann
C'est sous le signe d'Umberto Eco - l'érudition revisitée par la fiction - qu'il faut ranger
Daniel Kehlmann. Né en 1975 à Munich, il vit aujourd'hui entre Berlin, New York et Vienne, la ville où il a grandi et où il a ébauché une thèse sur Kant avant de caresser d'autres muses, celles de la littérature. Quatre romans modestes, d'abord, et puis, en 2005, les brillantissimes
Arpenteurs du monde qui ont battu tous les records de vente outre-Rhin. Kehlmann y retrace l'épopée parallèle de deux mousquetaires du savoir, Alexander von Humboldt (1769-1859) et Carl Friedrich Gauss (1777-1855).
Lumineuse idée, que de remettre en piste des personnages si différents puisque le premier fut un aristocrate bourlingueur et le second, un enfant du peuple casanier. Et pourtant Kehlmann parvient à les rassembler dans la même quête. Celle qui lança le géologue-botaniste Humboldt dans de rocambolesques périples à travers l'Amérique tropicale, dont il dévoila bien des mystères. Et celle qui poussa le génial Gauss à devenir "le prince des mathématiciens" : un virtuose de la physique et de l'astronomie qui, rivé à ses télescopes, déchiffra le cosmos et découvrit la fameuse courbe qui porte son nom.
C'est encore de l'univers des sciences que s'est inspiré Kehlmann pour écrire Les Esprits de Princeton - sous forme de théâtre, cette fois. Il y ressuscite le mathématicien Kurt Gödel, un rationaliste bientôt rattrapé par une démence paranoïaque qui, à la fin de sa vie, le condamna à s'enfermer dans des mondes parallèles où il croyait tutoyer l'au-delà. A lire également, Gloire, un livre à la David Lodge où Kehlmann tisse plusieurs histoires autour d'un même thème - la foire aux vanités, dans le petit microcosme des lettres et du cinéma.
Dernier livre paru : Les Esprits de Princeton (Actes Sud)
A.C.
Uwe Tellkamp
Dresde est une ville fantomatique où est né - en 1968 -
Uwe Tellkamp, qui fut d'abord commandant de char, passage obligé dans l'armée en RDA, avant d'entreprendre des études. Devenu médecin, il abandonna son métier en 2004, alors qu'il avait déjà publié des poèmes qui lui valurent le prix Ingeborg Bachmann. "Ma jeunesse s'est passée sous le signe du communisme, dit-il, un système dans lequel on écrivait plus qu'on ne parlait. Celui qui parlait trop était menacé et puis, d'un seul coup, le système s'est effondré et la parole s'est libérée."
Elle coule à flots dans la monumentale
Tour - seul roman traduit à ce jour -, une fresque qui a dépassé les 500 000 exemplaires en Allemagne après sa publication en 2008. Sujet : l'agonie de la RDA. Avec un scénario vertigineux, près de mille pages qui sont un document de premier ordre sur le naufrage de cette "terre engloutie". Ce sont ses ultimes soubresauts que décrit le romancier, entre la mort de Brejnev et l'automne 1989, en posant son zoom sur une famille bourgeoise des beaux quartiers de Dresde, les Hoffmann. Le père est chirurgien, il assiste sans broncher à la dégradation du système de santé et à celui d'une société gangrenée par la peur. L'oncle est éditeur, il doit se soumettre à la censure en se contentant, avec une ironie froide, de profiter des privilèges que lui octroie le Parti. Quant au fils, Christian, il aura à jouer le pire des rôles - celui de la victime expiatoire - lorsqu'il devra faire son service militaire : son goût pour la liberté et son insolence lui vaudront la prison, puis les travaux forcés. Tout est là : la main de fer de la police secrète, les combines, la pénurie, la propagande et la perfidie d'un régime où personne ne pouvait rester innocent. Pavane pour une Allemagne défunte, ce roman-fleuve résume le destin du communisme, sous la plume d'un héritier de Thomas Mann.
Dernier livre paru : La Tour (Grasset)
A.C.
Peter Schneider
Né en 1940 à Lübeck, le très remuant
Peter Schneider a fait ses études à Fribourg, à Munich et à Berlin, où il vit depuis les années 1970. A cette époque, il devint l'un des leaders de la jeunesse révoltée, aux côtés de Rudi Dutschke, et il changea ensuite de terrain de chasse pour se frotter à l'écriture. Avec cette consigne : "Le vrai domaine de la littérature, ce n'est pas le monde extérieur mais le monde intérieur, celui des secrets, des passions et des angoisses."
N'empêche, l'oeuvre de Schneider reste totalement chevillée à l'Histoire, à la politique et au destin complexe de l'Allemagne, depuis le nazisme jusqu'à la chute du Mur. S'ils analysent toujours ces événements du point de vue de l'individu, les livres de Schneider ne cessent de refléter des tourmentes collectives. Le mélange de dépit, de rage et de désenchantement qui a succédé à l'euphorie contestataire de Mai 68, dans le très autobiographique Lenz. La lourde suspicion et les multiples tracasseries professionnelles dont furent victimes les ex-gauchistes de la RFA, dans Te voilà un ennemi de la Constitution. Les excès de la chasse aux terroristes au sein d'une Allemagne livrée à la délation et à l'hystérie, dans Le Couteau dans la tête. Ou, dans Cet homme-là, le conflit éthique qui opposa deux générations tiraillées entre la culpabilité engendrée par le passé hitlérien et le désir de se libérer de ce fardeau inexpiable.
Et, dans Le Sauteur de mur, un de ses livres les plus célèbres publié en 1982, Schneider pose la question de l'identité allemande, une identité bafouée dans un pays divisé jusqu'à la schizophrénie : il met en scène un écrivain de Berlin-Ouest qui passe à l'Est pour rencontrer aussi bien des dissidents que des anonymes, des personnages souvent fatalistes qui, à force d'avoir construit un mur dans leur propre tête, ne sont plus capables d'affronter les dérives de l'Histoire. Peter Schneider ? Un "écrivain-baromètre" dont l'oeuvre interroge quatre décennies allemandes, avec toutes leurs contradictions et leurs impasses.
Dernier livre paru : Pour l'amour de Scylla (Grasset)
A.C.
Herta Müller
La romancière est née en Roumanie en 1953, au Banat, dans un village isolé appartenant à la minorité germanophone du pays. Fille d'une déportée, elle a grandi dans la peur et le désarroi avant de suivre des études littéraires à l'université de Timisoara, où elle ne tarda pas à rejoindre les mouvements clandestins qui luttaient contre Ceausescu. Traductrice dans une usine de machines industrielles à la fin des années 1970, elle sera congédiée pour avoir refusé de collaborer avec la Securitate et, en 1982, son premier recueil de nouvelles sera censuré avant qu'elle ne quitte sa terre natale - en 1986 - pour se réfugier à Berlin, où elle vit aujourd'hui. Ce déracinement est l'une de ses hantises, en tant que romancière, de même que la question de la langue, cette langue allemande qui fut pour elle une sorte de refuge face aux paroles gelées d'un régime qui, dit-elle, "avait détourné les mots à son profit".
Couronnée par le prix Nobel en 2009, l'oeuvre de
Herta Müller (Le renard était déjà le chasseur, La Convocation, Animal du coeur) pose un regard particulièrement amer sur la vie quotidienne dans la Roumanie totalitaire, les manoeuvres machiavéliques de la police secrète, les humiliations liées à la pauvreté et au contexte politique. Face à cette oppression de tous les instants, les mots sont les seules armes de la romancière, un combat dont il est aussi question dans un de ses livres les plus poignants,La Bascule du souffle, confession d'un garçon de 17 ans qui, en janvier 1945, parce qu'il appartient à la communauté germanophone de Transylvanie, sera expédié dans un camp de travail en URSS. C'est le calvaire de ce garçon condamné à cinq ans de déportation que raconte Herta Müller : malgré le froid et la faim, les poux et les épidémies, il tiendra le coup parce que son imagination délirante lui permet de résister aux souffrances. Lire Herta Müller, c'est se heurter de plein fouet à l'Histoire, une Histoire qu'elle tente de réécrire pour offrir au tragique sa part de rédemption.
Dernier livre paru : Animal du coeur (Gallimard)
A.C.
Eugen Ruge
Lunettes vissées sur le crâne et barbichette blanche, il n'a plus guère l'allure d'un jeune premier. Le Berlinois
Eugen Ruge a d'ailleurs déjà plusieurs pièces de théâtre et documentaires à son actif. Mais cet ancien physicien a attendu ses 57 ans pour publier son premier roman,
Quand la lumière décline, largement inspiré de l'histoire familiale. Un pavé au style clair et à l'envergure rare, qui a enchanté ses compatriotes. Il a reçu, l'an passé, le Deutscher Buchpreis, équivalent allemand du Goncourt, avant de s'écouler à plus de 350 000 exemplaires. Et, de fait, il y a de quoi s'enthousiasmer à la lecture de cette imposante saga autour de trois générations d'intellectuels de l'ex-Allemagne de l'Est.
Les premiers, Charlotte et Wilhelm, fervents communistes, décident en 1952 de rentrer de leur exil mexicain afin de participer à la construction de la jeune RDA. Leur fils, Kurt, les y rejoindra, après quelques années d'exil en Sibérie pour échapper au nazisme. Quant au petit-fils, Sacha, il grandit dans l'indifférence et l'ennui, rêvant bientôt de passer à l'Ouest...
Roman-fleuve écrit sur les bords de la Spree, Quand la lumière décline est taillé pour le cinéma : construction en flash-back, prises de vues alternées, décors sublimés. Mais, loin d'observer avec distance le déclin de l'illusion socialiste, le récit colle au plus près des personnages, de leurs espoirs, de leurs doutes, des tabous qui enveloppent et condamnent une génération après l'autre. Sans céder à l'"ostalgie" ambiante, sans rien taire non plus des difficultés nées de la réunification, Eugen Ruge signe le portrait froid et décapant d'une poignée d'hommes et de femmes brisés par leurs utopies, écrasés par un système sans visage. Avec une seule consolation : si la lumière décline à l'est du Mur, ce n'est du moins pas le cas de sa littérature.
Dernier livre paru : Quand la lumière décline (Les Escales)
Julien Bisson
Juli Zeh
Fille d'une traductrice et d'un ancien directeur administratif du Bundestag,
Juli Zeh - née à Bonn en 1974, aujourd'hui installée près de Berlin - est à l'évidence la principale figure de proue de la jeune littérature allemande. Après des études de droit international, elle a bifurqué vers l'écriture tout en prenant la relève des intellectuels qui, à la suite de Grass et de Böll, n'ont cessé d'intervenir dans le débat public : ce désir de s'engager l'a poussée à soutenir la coalition verte-rouge lors des élections de 2005, après avoir rapporté des Balkans - en 2001 - une enquête particulièrement amère sur le sort de ces populations abandonnées par la communauté européenne.
C'est en 2004, avec l'effrayante
Fille sans qualités, que Juli Zeh s'est définitivement imposée dans son pays. Elle s'y inspire de la tragique fusillade du lycée d'Erfurt - seize morts en 2002 - pour mettre en scène une adolescente qui sombrera dans la violence aveugle avec un cynisme déconcertant, une dérive qui permet à la romancière de souligner le profond désarroi d'une jeunesse tentée de choisir le camp du nihilisme, par désespoir et par peur de l'avenir.
Juli Zeh a ensuite fait un détour par le polar avec
L'Ultime Question et c'est au roman d'anticipation qu'elle s'est frottée en signant
Corpus delicti, qui se situe en 2057 dans un pays dictatorial où les habitants doivent s'astreindre à une redoutable discipline hygiéniste, sous haute surveillance policière, avec Big Brother dans le rôle du législateur. C'est dans ce cauchemar aseptisé que débarquera une biologiste allemande qui n'a qu'un seul tort : refuser d'obtempérer et de "se soumettre aux contrôles sanitaires obligatoires, au détriment de l'ordre public"... Dans ce récit à la Orwell, Juli Zeh ausculte tous les maux de nos sociétés soumises à la tyrannie du bien-être, et gavées d'interdits. C'est dire que les débats soulevés par la romancière sont assez brûlants pour être au coeur de l'actualité littéraire, outre-Rhin.
Dernier livre paru : Corpus delicti (Actes Sud)
A.C.
Ingo Schulze
Ingo Schulze est né en 1962 en RDA, à Dresde, une année après la construction du mur de Berlin, ce mur dont les pierres allaient servir de matériau à certains de ses romans. Après des études de lettres à Iéna, il a travaillé comme dramaturge pour le théâtre d'Altenbourg - aux confins de la Saxe - et c'est là qu'il assista au séisme de l'automne 1989 qui déboucha sur la réunification allemande. Il profita aussitôt de ce vent de liberté pour créer un hebdomadaire, l'Altenburger Wochenblatt, et, trois ans plus tard, il fut chargé de mettre sur orbite le premier "gratuit" de Saint-Pétersbourg, où il put observer un autre séisme, celui qui venait de secouer l'ex-URSS. A son retour en Allemagne, il s'installa à Berlin, où il vit aujourd'hui et où il signa les nouvelles rassemblées dans 33 moments de bonheur, autant de chroniques d'une Russie en pleine ébullition après l'effondrement du communisme.
Paru en 1998, le second livre de Schulze, Histoires sans gravité, est aujourd'hui considéré en Allemagne comme l'une des oeuvres les plus emblématiques de la réunification, une mutation de l'Histoire observée à travers le quotidien de citoyens tout à fait ordinaires de l'ancienne RDA. Pas de place, ici, pour les vieilles querelles politiques ni pour les règlements de comptes idéologiques : Schulze se contente de déployer un éventail de saynètes hyperréalistes - à la Perec ou à la Carver -, avec des personnages qui sortent de leur torpeur et retrouvent peu à peu le goût de la vie dans un pays rendu moribond par un régime essoufflé.
Et, en 2005, Schulze reviendra sur ces événements dans Vies nouvelles, un roman épistolaire dont le protagoniste raconte comment "l'Ouest est entré dans sa tête". On y retrouve la même minutie narrative et les mêmes effusions du vécu à la suite de la destruction du "rempart antifasciste" mais Schulze montre aussi comment l'ex-RDA s'est brutalement ouverte aux lois du marché et au capitalisme. Un monde peut-être aussi dangereux que le précédent puisque le diable finit par y débarquer, sous la forme d'un sosie de Méphisto...
Dernier livre paru : Adam et Evelyne (Fayard)
A.C.
Iris Hanika
Prédestinée par son prénom - Iris, la messagère des dieux - à communiquer ou à surprendre les émotions, les paroles, les pensées et les humeurs des humains,
Iris Hanika est une friponne. Elle brille par son génie de l'observation micro- sociologique, par sa sensibilité et son humour. Née le 18 octobre 1962 à Wizbourg (Franconie), qu'elle a quitté à 17 ans pour aller faire sa vie à Berlin, cette polyglotte tire sa subsistance de ses traductions de manuels d'informatique tout en poursuivant depuis dix ans une carrière d'écrivain. Sur ses cinq ouvrages publiés, un seul a été traduit en français à ce jour - paru chez Les Allusifs,
Une fois deux a été heureusement repris en Livre de poche.
Comme le suggère son titre, le roman campe deux personnages qui, au milieu de l'été berlinois, se sont rencontrés - exceptionnellement, car en général l'un et l'autre ne s'y rendent pas aux mêmes heures - dans un café de Kreuzberg. Voici Senta, une femme seule, employée d'une galerie d'art le plus souvent déserte qui, quoique lasse de ses échecs, ne cesse d'espérer la "félicité amoureuse", le mariage et les enfants. Et voilà Thomas, un homme seul, ingénieur système, qui ne s'autorise la félicité qu'après le travail, à raison de quelques chopes de bière. Dès l'instant où leurs regards se sont croisés, percutés, échangés, noyés, c'est comme si, sous la pression de ce désir tombé du ciel, chacun avait été brutalement dépouillé de son naturel, de ses réflexes ordinaires, de sa maîtrise familière. Emportée par son imagination, Senta est la plus déroutante des deux. A la violence du désir, elle oppose des comportements calculés pour paraître au maximum de son avantage. Au stade de l'exécution, sa stratégie échoue pitoyablement, au risque d'éloigner Thomas. Auteur d'une brillante variation, aussi grisante qu'un cocktail à base de Georges Perec, d'Anna Gavalda et de Michel Houellebecq, autour d'un thème pourtant rebattu, Iris Hanika a l'art de nous guider dans l'intimité de Berlin. Où, mieux que d'autres, certains quartiers inspirent d'éclatantes métaphores de la terreur ou de la félicité de l'amour.
Dernier livre paru : Une fois deux (Les Allusifs)
Philippe Delaroche
Christoph Hein
Né en 1944 en Basse-Silésie,
Christoph Hein ne fut pas autorisé à faire ses études en RDA, parce que, comme Schiller et Hölderlin, il était fils de pasteur... Ses parents l'envoyèrent donc dans un lycée de Berlin-Ouest et, à son retour de l'autre côté du Mur, il dut se contenter de métiers improvisés avant d'être assistant à la Volksbühne, le théâtre alternatif berlinois où il verra plus tard jouer ses propres pièces. Dès la fin des années 1970, il se lança dans l'écriture de nouvelles, autant de diagnostics des carences de la société est-allemande qui obéit servilement à un pouvoir de plus en plus autoritaire. Un pouvoir avec lequel Hein devra sans cesse ruser afin de contourner la censure.
Sa notoriété, il la doit à un roman emblématique, L'Ami étranger, écrit en 1982 sous le signe de Franz Kafka et de Robert Musil. Claudia, l'héroïne, est une femme sans ambitions, sans passions, presque sans qualités, dont la fadeur reflète un régime politique qui lamine tout, en condamnant les êtres à l'anonymat. Est-elle une simple victime du socialisme ou, au contraire, son indifférence est-elle une forme d'exil intérieur, seule résistance possible face à l'asservissement de son époque ? C'est sur cette ambiguïté que repose L'Ami étranger, remarquable mise en scène de la conspiration du silence derrière le rideau de fer. Une conspiration qui sous-tend un autre roman très célèbre de Hein, La Fin de Horn, où il montre comment la RDA a sournoisement censuré son passé, relié au IIIe Reich par une longue chaîne de compromissions et de lâchetés.
Comptant une dizaine de romans, des essais et de nombreuses pièces de théâtre, l'oeuvre de Hein ne cesse de faire entendre une voix discordante et dissidente, une voix qui continua de déranger après la réunification : l'auteur de L'Ami étranger fut, en effet, l'un des premiers écrivains à mettre en garde son pays contre l'euphorie qui suivit la chute du Mur. De quoi s'inscrire dans la lignée des grands réfractaires d'outre-Rhin, sous la bannière de Günter Grass.