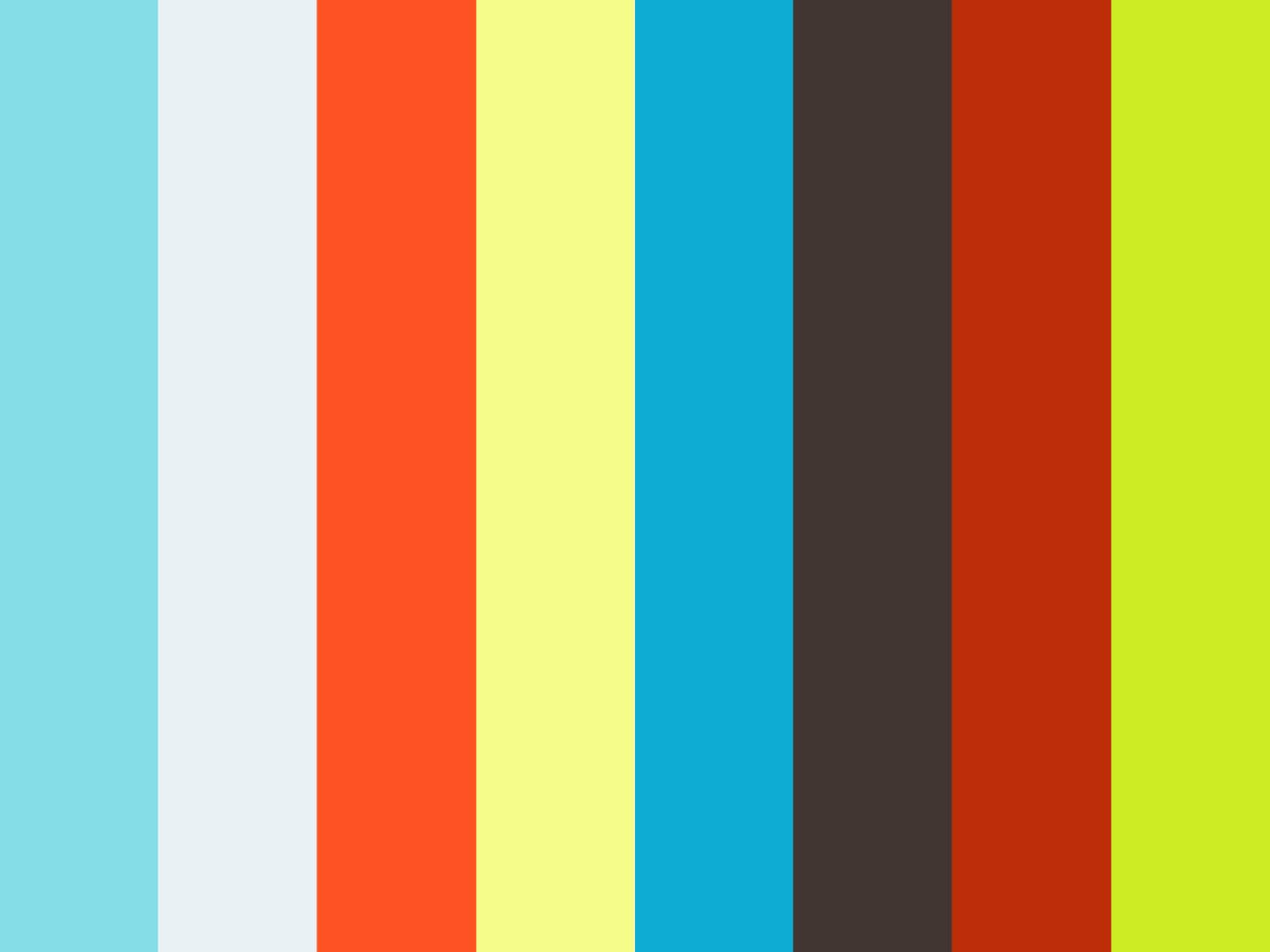Émile Zola è lo scrittore più popolare della Francia: alla fine del Ventesimo secolo, le collezioni di tascabili hanno venduto venticinque milioni di copie dei suoi romanzi. Nel nostro Paese, invece, Zola è poco letto e poco amato; ed è dunque molto proficua la recente edizione dei Meridiani, che pubblica nove romanzi in tre volumi. Da poco sono usciti Germinal, La terra, La bestia umana, curati in modo eccellente da Pierluigi Pellini e tradotti da Giovanni Bogliolo, Donata Feroldi e Dario Gibelli. Zola cominciò a scrivere Germinal, il più famoso e forse il più bello dei suoi romanzi, nell’aprile 1884, dopo aver studiato la questione mineraria, e dopo un viaggio a Valenciennes, il principale modello di Montsou, dove si concentrano le vicende del libro. Un anno più tardi lo pubblicò in quarantamila esemplari: una tiratura alta anche oggi.
In primo luogo, Germinal è un libro nero. La pianura nuda è dominata da una notte senza stelle, illuminata dai rari fuochi azzurri degli altiforni e da quelli rossi dei forni a coke: essa è spazzata da una tramontana gelida con grandi soffi che si succedono regolari come colpi di falce; oppure bagnata dalla pioggia che scende lenta, cancellando ogni cosa in fondo al suo monotono picchiettio. La notte seppellisce la terra come un sudario. Si moltiplica nel cuore della miniera, ispessita dalla polvere di carbone sospesa nell’aria, e appesantita dai gas che gravano sugli occhi dei minatori. Sentiamo un rumore sordo, che sembra provenire dalle viscere della terra, e che nasce dallo sfiatatoio della grande pompa: un respiro lungo, greve, incessante, simile all’ansimare strozzato del mondo. Tutto, la notte, la miniera, il respiro dello sfiatatoio, è tenebra; e questa tenebra non è un’assenza di colore, ma, come diceva Huysmans, il colore supremo, la molteplicità di tutti i colori, che occupa in modo stabile la mente di Zola.
La miniera è accucciata in fondo a un avvallamento: con edifici tozzi di mattoni e una ciminiera alta trenta metri, ritta come un cono minaccioso. Il suo aspetto è malvagio: sembra una bestia ingorda, un mostro accoccolato per divorare la gente. Zola si sforza di descriverla: insiste, ripete, insiste ancora, fallisce; finché, secondo la profonda inclinazione della sua natura, parla, con una specie di religioso tremore, di un «tabernacolo», in cui si nasconde, accucciato e satollo, il dio al quale tutti i minatori e tutti gli uomini offrono la propria carne.
Questo dio è inanimato: è una cosa nella sua essenza profonda: ma subito diventa animalesco; il pozzo inghiotte gli uomini a bocconi di venti o trenta per volta, e li manda giù per la gola, come se non li sentisse nemmeno passare. Ciò che è animalesco diventa umano: i cavalli, che stanno chiusi in fondo alla miniera e non risalgono mai alla luce, rivedono con la mente il mulino dove sono nati, continuamente battuto dal vento, e fanno inutili sforzi per ricordare l’infanzia. Intanto la pompa della miniera continua a soffiare con lo stesso respiro lungo e greve: il respiro di un orco umano che nulla può saziare.
Passando dal simbolo alla realtà, Zola descrive gli uomini che affollano la pianura di Montsou. Essi non sono, in realtà, uomini, ma insetti o spettri. In fondo alla miniera, si agitano forme fantomatiche, lasciando intravedere un’anca, un braccio nodoso, una faccia rabbiosa, imbrattata di polvere di carbone come per commettere meglio un delitto. Essi sudano: ansimano: le giunture dei corpi scricchiolano, ma senza un lamento, con l’indifferenza dell’abitudine, come se vivere così piegati fosse il destino comune di tutti gli uomini. Si spogliano: scavano la roccia: si intridono di fanghiglia nera fino al capo; come talpe in fondo a una tana, sotto il peso della terra, senza più fiato nei corpi arroventati.
Quando la Compagnia mineraria aggrava le loro condizioni di vita, i minatori entrano in sciopero. I borghesi trovano divertente lo sciopero: ma, in fondo alla loro allegria forzata, c’è una sorda paura, tradita da occhiate involontarie. Sul piazzale della miniera grava un pesante silenzio: quella di Montsou è una fabbrica morta: i grandi cantieri sono vuoti; nel cielo di dicembre, tre o quattro vagoni abbandonati hanno la muta tristezza delle cose dimenticate. In questo momento, alla tradizionale disciplina dei minatori si aggiunge un orgoglio da soldati: gente fiera del proprio mestiere, che dalla lotta quotidiana contro la morte ha appreso l’esaltazione del sacrificio.
Tra i minatori di Montsou, giungono estranei. Étienne Lantier, che viene dalla città, appare in altri volumi dei Rougon-Macquart, il grande ciclo di Zola. Egli non tollera i doni della Compagnia: detesta i borghesi: non vuole farsi ridurre come una bestia accecata e schiacciata; ma immagina una rigenerazione universale di popoli senza una goccia di sangue. Suvarin è un anarchico, che viene da Pietroburgo. «Piantatela — grida — con la vostra evoluzione! Appiccate il fuoco ai quattro angoli della terra, sterminate i popoli, radete al suolo tutto quanto. Quando non resterà più niente di questo mondo, allora forse ne nascerà uno migliore. Lo volete capire? Bisogna distruggere tutto. Sì, l’anarchia. Più niente. La terra lavata dal sangue, purificata dall’incendio...!».
Lo sciopero si estende e diventa violento. Quando i minatori arrivano al pozzo di Gaston-Marie, duemilacinquecento forsennati spaccano e spazzano via tutto, con la forza impetuosa di un torrente in piena. Ribaltano i fornelli, svuotano le caldaie, devastano gli edifici. Si gettano sopra la pompa, come se fosse una persona a cui vogliono togliere la vita: la massacrano a colpi di mattoni e sbarre di ferro. Allora l’acqua comincia a sgorgare. Quando esce completamente, un ultimo gorgoglio sembra il singulto di un agonizzante. Lo sciopero dura due mesi. La rabbia, la fame, le scorribande trasformano i placidi volti dei minatori di Montsou in fauci di bestie feroci. I raggi del sole al tramonto insanguinano la pianura. Il nero del libro diventa rosso, scarlatto, accrescendo la propria violenza tenebrosa. I minatori si chiudono in casa, in preda alla fame e alla ostinazione passiva. La loro forza cieca divora sé stessa.
Intanto Suvarin è sempre più assorbito in un’idea fissa, che sembra brillare come un chiodo d’acciaio in fondo ai suoi occhi chiari. Egli sabota la miniera. Poi si allontana senza guardarsi alle spalle nella notte tenebrosa: con la sua aria tranquilla, va verso lo sterminio, dovunque ci sia dinamite per far saltare uomini e città.
Sottoterra, scorre il Torrente, un mare inesplicato, con le sue tempeste e i suoi naufragi, che agita i propri flutti neri a trecento metri dalla luce del sole. La miniera si riempie d’acqua. La grande pompa ansimante non riesce a smaltirla. Il rivestimento del pozzo si stacca. In alto si sente una serie di sorde detonazioni: tavole di legno si fendono e si schiantano in mezzo al continuo e crescente frastuono del diluvio. Si sentono bruschi rimbombi: rumori irregolari di cadute profonde, seguiti da lunghi silenzi. La ferita della miniera si allarga: la frana, cominciata in basso, si avvicina alla superficie. Una prima scossa fa tremare il terreno, seguita da una seconda. Da quel momento il suolo non smette di tremare: un susseguirsi di scosse, cedimenti sotterranei, boati di vulcani, e infine un’ultima convulsione. L’alta ciminiera crolla in blocco, bevuta dalla terra come un cero colossale. Tutta la miniera sprofonda in un lago d’acqua melmosa: mentre i cavalli, chiusi nelle stalle sotterranee, impazziscono con nitriti furibondi.
Nel pozzo rimane Étienne, insieme a una ragazza, Catherine Maheu, che egli ama di un amore contrastato. La lampada si spezza. Sopra di loro, scende la notte assoluta. Entrambi accusano ronzii alle orecchie: sentono i rintocchi furiosi di una campana a martello, il galoppo interminabile di una mandria sotto un rovescio di grandine. Étienne avvinghia Catherine e la possiede: «Quella fu finalmente la loro notte di nozze, in fondo a quella tomba, su quel letto di melma, per l’ostinato bisogno di vivere un’ultima volta». Catherine muore. Étienne viene salvato e portato in alto, alla luce del sole. Come i grandi romanzi romantici, Germinal conosce il proprio senso ultimo nella fusione di Eros e Thanatos, amore e morte.
Il titolo del bellissimo libro indica il settimo mese, Germinal, nel calendario della rivoluzione francese: dal marzo all’aprile. Al tempo stesso, annuncia il ritorno e la vittoria della primavera: la nascita, la vita, la germinazione. Tutte le cose germinano: anche ciò che è morto, o non è mai esistito: persino Catherine annegata in fondo al pozzo; eppure esse sono nere, come l’eterna notte senza stelle che apre il romanzo. I libri di Zola sono sempre così: realistici e onirici, razionali e mistici, riuniscono disperatamente e trionfalmente gli estremi dell’universo.