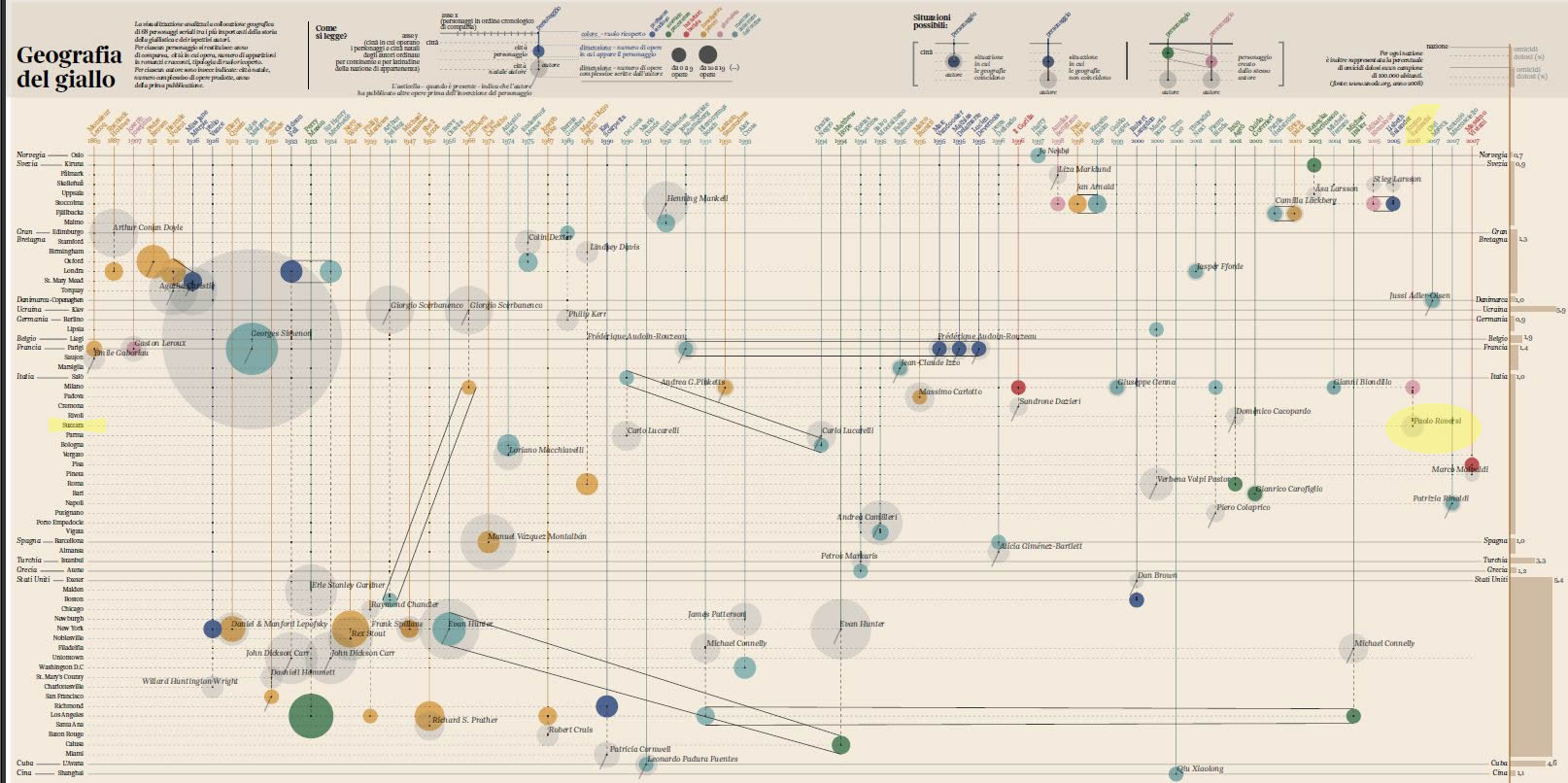Votre «Roman du mariage» se situe au début des années 1980. Le mariage, s’il était un objet romanesque dans la littérature du XIXe siècle (et particulièrement Jane Austen) et un enjeu social pour les femmes, ne l’était plus après la révolution des mœurs des années 1960 et 1970. Aujourd’hui, à l’heure du mariage pour tous, le mariage redevient-il un enjeu?
Jeffrey Eugenides Il est intéressant de constater à quel point le mariage conserve une importance et une signification aussi bien romanesques que sociales, même après cette période où il semblait avoir perdu tout son sens. Ce roman vise à explorer ce qu’il en reste et s’il est encore possible d’en faire le cœur d’une intrigue, alors que tant de bouleversements nous ont éloignés de ce qu’il représentait au XIXe siècle.
Le combat pour le mariage gay pour la liberté d’avoir non seulement un/e partenaire mais un mari ou une femme, de se lier par contrat à l’être aimé, prouve le pouvoir que le mariage continue d’exercer dans nos vies. Auparavant, je croyais que c’était une chance pour les homosexuels de pouvoir se situer hors de l’économie du mariage, d’échapper à cette idée fixe. Or il n’en est rien. Même si je pense qu’ils devraient réfléchir avant de s’engager dans cette voie !
Mais à mesure que les Etats américains légalisent le mariage gay j’ai pu constater que les homosexuels et les lesbiennes se sentent rassurés, plus à l’aise pour exprimer publiquement leur affection, soulagés de pouvoir dire qu’ils ont un mari ou une femme. Cela peut paraître stupide et anachronique en 2013, mais le mariage permet aux gens de se présenter comme un couple, d’être reconnus par la société comme une force en son sein. Et je ne crois pas qu’on puisse comprendre pleinement l’esprit du mariage et son poids symbolique si on n’a pas été confronté directement à l’interdiction de se marier.
Qu’est-ce qui a changé fondamentalement dans le mariage et qu’est-ce qui reste identique?
Je n’essayais évidemment pas de reproduire un roman de Jane Austen. Je voulais simplement étudier comment le mariage affecte la mentalité d’un individu, ses attentes affectives, sa vision de l’amour. Comme Mme Bovary, on grandit en lisant des romans et on se met à nourrir des idéaux et des fantasmes romantiques. Au départ, je ne me posais pas vraiment cette question des changements ou des similitudes entre deux époques, mais en écrivant j’ai découvert que certains éléments demeuraient tout à fait pertinents et actuels, le premier d’entre eux étant évidemment l’argent.
Tous les grands «romans de mariage», de Jane Austen à «Portrait de femme» de Henry James, tournent autour de cette question: comment trouver un mari ? Et quelle est sa fortune ? Si une femme trouve un homme suffisamment riche et qu’il se révèle bon et affectueux, elle est parée pour la vie. Inversement, dans «Portrait de femme», c’est elle qui est riche, ce qui devrait lui procurer liberté et indépendance et la dispenser de l’obligation de se marier ; mais sa fortune attire les hommes, notamment celui qu’elle épouse et qui se révèle être un mauvais mari.
Cette disparité de fortune se retrouve encore dans les personnages de mon roman: Leonard a un complexe d’infériorité, il se sent financièrement et socialement indigne de l’aristocratique Madeleine, et va jusqu’à manipuler le traitement médical qu’il suit pour ses troubles bipolaires afin de surmonter cet obstacle.
Inversement, il est beaucoup plus facile aujourd’hui d’échapper à un mariage malheureux. On ne pourrait plus écrire «Anna Karénine»: lorsqu’elle décide de divorcer, la société la rejette et l’ostracise, on lui interdit de voir son fils, elle perd tout hormis son amant. De nos jours, une femme peut divorcer en conservant la moitié des biens du couple et la garde de ses enfants. C’est un changement fondamental. Je parle ici de changements qui affectent l’intrigue d’un roman de mariage.
Dans la vie, les principaux changements portent sur la répartition des rôles au sein du couple. Pour la génération de mes parents, ces rôles étaient bien tranchés: mon père gagnait l’argent du ménage, ma mère était femme au foyer. Aujourd’hui, on assiste à un brouillage des rôles, et c’est cette question désormais qui constitue le vrai champ de bataille au sein du mariage: comment répartir les tâches ménagères, l’éducation des enfants, l’implication dans la vie professionnelle ? Il n’y a plus de règles.
Nous vivons donc une période de transition, voire de crise, mais c’est exaltant car tout est à réinventer. Dans «Un homme amoureux», l’un des volumes de son autobiographie fleuve, l’écrivain norvégien Karl Ove Knausgaard raconte comment il tente à la fois d’écrire et d’élever son fils en Suède, un pays qui impose un strict égalitarisme entre les parents. Intellectuellement, il y croit, mais en fait il le vit très mal, il a l’impression de ne plus être un homme. C’est un tableau très drôle et très franc du mariage actuel et de la place de l’homme au sein du couple, forcé d’y jouer un rôle dont il ne veut pas nécessairement. Voilà pour moi le plus grand changement qu’a connu le mariage dans la réalité sociale.
Quel est le meilleur «roman de mariage» jamais écrit ?
«Portrait de femme» de Henry James. Mon héroïne Madeleine a beau être une inconditionnelle de Jane Austen, je ne partage pas sa passion à ce point. Ce que j’apprécie dans les romans de mariage plus tardifs, à partir du milieu du XIXe siècle, c’est qu’ils ne s’achèvent pas sur le mariage mais accompagnent l’héroïne dans sa vie conjugale. «Madame Bovary» entre évidemment dans cette catégorie. Que se passe-t-il quand le mariage devient compliqué voire tragique, quand intervient l’adultère ? Je trouve ces enjeux bien plus intéressants.
Les romans de mariage tardifs ont plus de profondeur psychologique, ce qui les rend plus modernes. «Portrait de femme» est un roman incroyable par ce qu’il dit de la société et de la place qu’y occupe la femme. Il conserve les éléments archétypiques d’un roman de Jane Austen (qu’on retrouve jusque dans «le Journal de Bridget Jones»), comme la prolifération de soupirants entre lesquels il faut choisir, mais il s’aventure ensuite en territoire beaucoup plus sombre. Les personnages y commettent de terribles erreurs. Ce roman n’a rien d’une comédie, alors que ceux de Jane Austen, dans la mesure où ils se terminent par un mariage, sont fondamentalement des comédies.
Les trois héros de votre livre sont étudiants à l’université de Brown (à Providence, Rhode Island) en 1982, en pleine vogue de la «French Theory». A la même époque, vous avez étudié à Brown University la littérature et la sémiologie…
Je n’y ai suivi qu’un cours de sémiotique littéraire, où j’ai étudié Barthes, Derrida, Umberto Eco. C’est de là que vient ma maigre compétence sur le sujet. J’y suis venu assez tard. Brown était une université pionnière en ce domaine. Lorsque j’y étudiais, les sémioticiens étaient en train de se constituer en département à part entière, alors qu’avant ils étaient rattachés au département d’anglais, ou d’études cinématographiques par exemple.
Cela a constitué une vraie bataille. Beaucoup d’universitaires rejetaient les théories de la déconstruction, qui leur semblaient détruire toute leur conception de la littérature. Le débat était assez houleux entre ces deux factions, et un étudiant novice en théorie littéraire se trouvait dans la même position qu’un enfant dont les parents divorcent: il fallait choisir son camp, et comment choisir entre deux personnes également appréciées, un professeur à l’ancienne qui enseignait Shakespeare et un autre plus audacieux qui nous faisait découvrir Barthes. On se sentait écartelé.
J’étais plus à l’aise face au modernisme, à la métafiction et autres expériences littéraires d’avant-garde. Et sans que je m’en rende compte à l’époque, tous ces penseurs m’ont beaucoup influencé, car ils lançaient un défi à l’aspirant écrivain que j’étais. Je savais déjà que je voulais consacrer ma vie à la littérature, et ils semblaient affirmer que la littérature était dans une impasse. La théorie de la mort de l’auteur me faisait craindre que ma vocation ne soit mort-née, que la seule voie d’écriture encore possible ne réside dans la théorie littéraire plutôt que dans la fiction romanesque.
Je n’aimais pas cette idée, mais j’étais très frappé par leurs conceptions de la littérature et de son destin, par leur dénonciation d’une certaine fiction réduite à un ensemble de codes figés. Je ressens encore leur influence. Mais j’ai toujours voulu concilier leurs vues et mon attachement au roman, à la cohérence narrative, en m’efforçant d’aller de l’avant. J’ai trouvé très utile de devoir me définir en opposition à cette vision pessimiste. Mais j’ai eu des moments de doute et de découragement.
De tous les théoriciens français de la littérature que vous évoquez dans ce livre, avec lequel vous sentez-vous le plus d’affinités ?
Roland Barthes a toujours été mon préféré. Pour être franc, c’est le seul que je prenais plaisir à lire — quoique inégalement selon les livres. Les autres théoriciens, je devais lutter pour les comprendre. Mais Barthes est non seulement un grand penseur mais un merveilleux écrivain, au style plein de charme et de vivacité. Voilà pourquoi il joue un tel rôle dans mon roman.
Eprouvez-vous de la nostalgie pour vos années passées à la Brown University?
En Europe, on me demande souvent pourquoi les années d’université inspirent tant les écrivains et les cinéastes américains. Si nous éprouvons une telle nostalgie, c’est parce que notre entrée à l’université constitue notre première expérience de la liberté. On quitte le foyer familial pour un environnement complètement artificiel où l’on vit entouré d’autres jeunes gens soudain libres et encore inexpérimentés. On découvre des livres, des drogues, le sexe, la vie. Et ensuite, on doit plonger dans la vie professionnelle.
L’université constitue donc une parenthèse enchantée que l’on n’oublie jamais. Le contexte géographique joue aussi un rôle: vivre en vase clos sur un campus, ce n’est pas comme habiter Paris et suivre des cours à la Sorbonne !
A 20 ans, vous avez beaucoup étudié la théologie à Brown. Qu’est-ce que cela vous a apporté?
J’ai été baptisé selon le rituel orthodoxe grec, sans doute pour faire plaisir à ma grand-mère, mais je n’ai pas reçu d’éducation religieuse, et je suis allé à l’école publique. Mes parents n’étaient pas pratiquants, ils étaient même agnostiques sinon athées. Lors de mon premier séjour à Paris, à 20 ans, j’ai visité des cathédrales, et je me suis interrogé sur cette foi collective qui avait non seulement engendré de tels monuments mais façonné une bonne part de l’histoire de l’Occident, mais qui m’était complètement étrangère. Je voulais donc combler mon ignorance.
Par ailleurs, beaucoup des écrivains que je lisais avaient été des chrétiens fervents. Comment comprendre «le Paradis perdu» de Milton sans une connaissance de ses enjeux théologiques ? J’ai donc étudié la religion pour pouvoir mieux apprécier la littérature. Et je me suis pris au jeu ! Et cela faisait écho à mes interrogations de jeune homme sur le sens de la vie et l’origine du monde. J’éprouve encore le tourment existentiel de cette interrogation.
Comme votre héros Mitchell, vous avez pris une année sabbatique à 21 ans pour aller en Inde comme bénévole au foyer créé par Mère Teresa pour les mourants. Qu’a été votre expérience?
Ce fut une expérience brève mais mémorable. Je voulais me mettre à l’épreuve en m’exposant à un contexte difficile. Je n’avais jamais rien vécu de tel, jamais eu à m’occuper de quelqu’un, jamais vu personne mourir. Je voulais mieux me connaître, savoir si j’étais capable de surmonter mon narcissisme et mon égoïsme, de faire preuve de dévouement envers un inconnu misérable et agonisant. Cela n’a pas été totalement concluant: j’étais sujet à l’auto-apitoiement, et il y avait une part de narcissisme à relater ensuite cette expérience en la dramatisant.
Mais je me suis montré tout de même moins indigne que je ne le craignais. A cet âge, j’étais totalement inexpérimenté, je me demandais ce que je ferais de ma vie, et j’étais en quête d’une expérience extrême. Or il me semblait plus radical et plus rebelle de m’intéresser à la religion et de rejoindre Mère Teresa que d’arborer une crête punk verte comme certains de mes camarades de fac !
Je n’ai fait qu’apercevoir Mère Teresa à la messe, je l’ai surtout connue par personnes interposées. Apparemment, elle avait un côté très carré, très brut. Une jeune Américaine de 19 ans, qui avait passé pas moins de six mois à travailler dans ce foyer, lui a demandé la permission de prendre une semaine de vacances en Thaïlande. Et Mère Teresa a répondu: «La charité ne prend pas de vacances!»
Votre père était un fils d’immigrés grecs. Dans votre jeunesse, étiez-vous perçu comme «ethniquement différent»?
Un peu, oui, mais c’était le cas de tout le monde. Au lycée, il y avait encore un clivage entre les WASP d’une part, qui se considéraient comme des aristocrates sous prétexte que certains étaient apparentés aux grandes familles industrielles de Detroit comme les Ford, et d’autre part, les descendants d’immigrés italiens, libanais, grecs, polonais venus travailler dans les usines automobiles. Mon grand-père tenait un bar où les ouvriers venaient manger et boire. La génération suivante s’était un peu embourgeoisée, et nous vivions dans les mêmes quartiers résidentiels que les WASP. Un certain sentiment d’exclusion persistait dans cette société stratifiée, mais il ne faut pas oublier qu’à Detroit le véritable fossé était celui séparant les Blancs des Noirs.
Vous avez des origines mi-grecques mi-irlandaises. Quel Américain êtes-vous?
Comme tous les Américains, je suis bâtard ! Ma lignée irlandaise, du côté maternel, s’est établie dans le Kentucky dès le XIXe siècle. Ils appartiennent à un monde de petits Blancs, portés sur la bouteille et souvent sur la religion, à l’accent sudiste très prononcé, et que personne ne percevrait autrement que comme profondément américain. Je me considère comme profondément américain. J’ai beaucoup d’affinités avec l’Europe, j’y suis peut-être même plus à l’aise qu’aux Etats-Unis, mais je reste un Américain du Middle West.
Vous êtes né à Detroit en 1960 et y avez passé votre enfance et adolescence. Vous avez vu la crise frapper la ville.
Dans ma petite enfance, Detroit était la quatrième ville des Etats-Unis, et elle bouillonnait de vie et d’activité. C’était une ville prospère, même si elle n’avait pas la démesure de New York ou de Chicago. Quand j’allais rendre visite à mes parents sur leur lieu de travail au centre-ville, j’aurais pu me croire à Boston. Il y avait des institutions culturelles très dynamiques, de merveilleux musées, des salles de concert.
Après les émeutes de 1967, on a vu la ville littéralement s’effondrer: des immeubles brûlés, murés, rasés. Le taux de criminalité a monté en flèche, les gens déménageaient ou n’osaient plus s’aventurer dans le centre-ville. Cette déliquescence a coïncidé avec mon enfance, et à cet âge je n’ai pas compris ce que ce phénomène avait d’aberrant. Je croyais que c’était la norme.
Mais cette jeunesse à Detroit m’a mis en contact avec des réalités américaines: la puissance et l’automatisation de l’industrie automobile, la présence de la guerre à travers l’industrie de l’armement, la culture populaire avec la musique des artistes de Motown… Avant d’être célèbres, Stevie Wonder et les Supremes avaient joué dans un restaurant tout près de chez moi ! C’était l’Amérique dans tous ses aspects. Et comme l’Amérique tout entière, Detroit a ensuite connu le déclin de son industrie, mais aussi des antagonismes raciaux croissants. On avait beau être loin du Sud, de ses plantations et des champs de bataille de la guerre de Sécession, les retombées de l’esclavage se faisaient encore sentir à ma porte, en plein Middle West.
Aujourd’hui, Detroit est dépeuplée, au bord de la faillite, et désormais sous tutelle de l’Etat. Ses administrateurs provisoires veulent la renflouer en vendant tous ses actifs. Ils envisagent même de vendre les collections d’art du Detroit Institute of Art, un des plus beaux musées américains !
Quels sont les trois livres que vous emporteriez sur une île déserte ?
Le premier qui s’impose, c’est évidemment «Anna Karénine», car c’est le roman que je relis le plus souvent. Sur une île déserte, il vaut mieux emporter de gros romans ! Je prendrais aussi la Bible. Pour le reste, le choix varie selon l’humeur du moment. Aujourd’hui, je serais tenté de sélectionner l’œuvre autobiographique de Karl Ove Knausgaard, car c’est un énorme cycle de six volumes ! J’ai souvent aussi envisagé «Herzog» de Saul Bellow, que j’aime à relire. Mais j’opterais peut-être pour une anthologie de poésie anglaise, à cause de son abondance et de sa diversité.
Propos recueillis par François Armanet


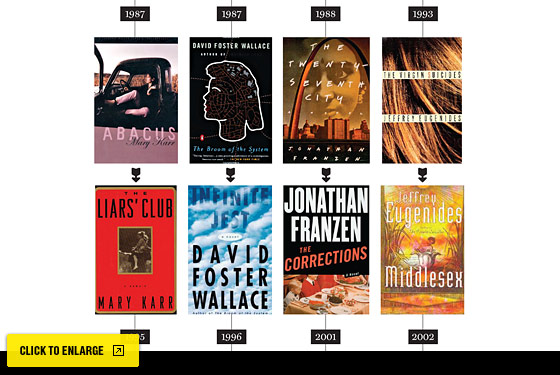








.jpg)