Depressioni e paure dopo «Guerra e pace»
«Dio è un'incognita, senza la quale nulla esiste»
Pietro Citati
"Corriere della Sera", 2 luglio 2013
Quali impressioni sconvolgenti destano, in chi esca dalla lettura di Guerra e pace e di Anna Karenina, i racconti tolstojani degli anni ottanta! Là, anche dove il destino si accaniva con più ferocia sulle creature di luce, avevamo l'impressione della libertà, della ricchezza, della varietà, della molteplicità di connessioni della vita; e con quale gioia ne percorrevamo i labirinti. Le Memorie di un pazzo, la Morte di Ivan Il'ic, Il diavolo, La Sonata a Kreutzer sono invece storie di un'ossessione: ossessione di una malattia psicologica, della morte, dell'eros, dell'odio. Come se avesse dimenticato i colori della primavera e dell'estate, ora Tolstoj vive al chiuso, prigioniero del chiuso, tetramente trionfante nella propria claustromania. Non c'è libertà ma costrizione: non respiriamo ma soffochiamo. Se là Tolstoj intrecciava tutte le dimensioni e i toni diversi, facendoli echeggiare uno nell'altro, ora egli sceglie una sola dimensione, un solo tono, in capolavori di cupa monotonia. Kafka ha molto amato alcuni di questi racconti.
Le Memorie di un pazzo, scritte nel 1884, fingono di essere l'autobiografia di un proprietario di terra: mentre, in realtà, rivelano gli acutissimi punti di crisi nella tarda esistenza di Tolstoj. All'inizio siamo nel 1869, subito dopo il completamento di Guerra e Pace, «quest'orgia», come confessò più tardi alla cugina Aleksandra. Tolstoj si sentiva abbandonato dalla fantastica e lucidissima ebbrezza dove aveva abitato per qualche anno, e senza la quale «non è possibile vivere». Aveva vissuto immerso nella musica continua della vita: ora, all'improvviso, si sentiva gettato fuori dall'esistenza, che si arrestava davanti ai suoi occhi, fissa, immobile, sclerotica, funeraria. Se la vita si era arrestata così all'improvviso, come poteva non arrestarsi anche lui? Guardava tutte le cose come se fosse stato un morto tra i morti: non vedeva più quanto c'era da vedere: non sentiva più quanto gli altri sentivano; ogni piacere intellettuale e poetico era perduto. Non desiderava più nulla.
* * *
Il protagonista delle Memorie di un pazzo decise di lasciare la propria casa insieme al suo servo, per vedere un possedimento con un grande bosco, che desiderava acquistare. Quando scese la sera, viaggiava in carrozza, per metà assopito. All'improvviso si svegliò, perché l'aveva attraversato non so quale terrore. Gli balenò in mente che non avrebbe dovuto a nessun costo spingersi in queste contrade remote, che sarebbe morto quaggiù, lontano da casa. E gliene venne un brivido. Incominciò a provare una stanchezza, un desiderio di sosta. Aveva l'impressione che entrare in una casa, vedere gente, bere del tè e sopratutto dormire, l'avrebbe risollevato. Decise di pernottare nella città di Arzamàs. Arrivò alla casa di posta: era bianca, e gli sembrò tremendamente triste, tanto da dargli un nuovo senso di ribrezzo. Smontò a terra adagio adagio. Entrò. C'era un corridoietto. Un uomo sonnolento, con una macchia su una guancia (quella macchia gli sembrò orribile) gli indicò una stanza con la mano.
Era una cameretta tetra, quadrata, bianca di calce, con una sola finestra dalle tende rosse. Che la cameretta fosse quadrata, gli riuscì stranamente penoso. Così, per mezzo del suo protagonista, Tolstoj penetrò per la prima volta nel mondo quadrato: proprio lui che aveva rappresentato la vita come qualcosa di sinuoso, circolare, femminile. Una volta il quadrato era per lui il segno dell'intelligenza astratta, dei programmi e dei propositi: ora, nella casa di posta di Arzamàs, diventa l'incarnazione degli orrori che germogliano tra le pareti della nostra mente.
Mentre il servo metteva su il samovàr, il protagonista si allungò sul divano. Non dormiva. Gli faceva paura alzarsi, allontanando il sonno: perfino stare seduto in quella camera gli faceva paura. Cominciò ad assopirsi. E dovette prender sonno, giacché — quando riaprì gli occhi — nessuno c'era più nella stanza, ed era buio. Riaddormentarsi (lo sentiva) non era possibile. Perché era venuto quaggiù? Dove andava portando sé stesso? Da che, e dove fuggiva? «Io fuggo — si diceva — da qualcosa di tremendo, e non posso sfuggirne. Io sto sempre con me stesso, e sono proprio io che riesco tormentoso a me stesso. Eccolo, quest'io: sono tutto qui». Avrebbe voluto addormentarsi, perdere coscienza, ma non poteva. Non poteva allontanarsi da se stesso.
Le sensazioni che il protagonista provò — il terrore indeterminato, la camera bianca e quadrata, l'unica finestra rossa, la angoscia del sonno e dell'insonnia, l'orrore di sé stesso — sono le prime, acutissime sensazioni di un accesso di mania depressiva, che viene fisicizzato, trasformato in oggetti, e proiettato all'esterno. Quando il protagonista-Tolstoj uscì nel corridoio, credette di allontanarsi da ciò che lo faceva soffrire. Ma quello gli era uscito dietro, e spandeva su tutto la sua tetraggine: sempre a un modo. «Ma insomma — disse a sé stesso — di che cosa m'angoscio, di che cosa ho paura?». «Di me — rispose senza suono la voce della morte — Io sono qui». Un brivido gli fece aggricciare il corpo. «Sì, la morte. Verrà, quella, verrà: già eccola; eppure non deve esistere». Vedeva, sentiva che la morte incombeva sopra di lui e, nello stesso tempo, sentiva che essa non doveva esistere. Questa lacerazione interiore era spaventosa. Tentò di scrollarsi di dosso quell'orrore. Trovò un candelabro di bronzo, con la candela ridotta a un mozzicone, e l'accese. Il candelabro, la fiamma rossa della candela, tutto intorno a lui gli ripeteva la stessa cosa. «Non c'è nulla nella vita: c'è la morte. Eppure essa non deve esistere».
Il protagonista provò a pensare a ciò che di solito lo interessava: l'acquisto dei terreni, sua moglie. Ma tutto era sparito sotto lo spavento di questo disfarsi della propria vita. Bisognava dormire. Appena coricatosi, balzò su dal terrore. E un'angoscia, un'angoscia — un'angoscia nell'animo, identica a quella che precede il vomito: solo spirituale. Poteva sembrare un orrore della morte, ma se rifletteva, era il morire della vita che lo spaventava. La vita e la morte confluivano in una cosa sola. Ancora una volta provò a dormire: sempre quel medesimo orrore, rosso, bianco, quadrato. Dolore straziante, e senso straziante di aridità e di rancore: non una stilla di bontà, ma solo un eguale, calmo rancore contro sé stesso e contro ciò che o chi l'aveva creato.
Quando Tolstoj tornò a casa, riprese a vivere come prima. Bisognava che la sua vita si svolgesse senza mai sosta, e, sopratutto, senza mai uscire dalle condizioni abituali. Come uno scolaro recita senza pensarci una lezione imparata a memoria, allo stesso modo lui doveva vivere la vita, per non cadere di nuovo in balia di quella angoscia, che per la prima volta l'aveva assalito ad Arzamàs. L'acutissima mania depressiva diventò abitudine. Viveva apatico, indifferente a tutto e a tutti: triste, abbattuto, senza emozione e senza gioia, per giorni e settimane intere: ogni fiamma sembrava spenta nella sua anima: aveva voglia di piangere: temeva di essere malato; gli sembrava che tutto fosse finito per lui, e non gli restasse che morire.
* * *
Anni dopo, il protagonista di Memorie di un pazzo dovette andare a Mosca. Arrivò d'ottimo umore, e scese all'albergo. Entrò nella sua piccola camera. Il greve tanfo del corridoio gli stava nelle narici. La cameriera accese la candela. La fiamma calò, poi si ravvivò, illuminando il turchino strisciato di giallo delle pareti, il tramezzo, il tavolo logoro, il divanetto, lo specchio, la finestra e l'angustia di tutta la cameretta. E d'improvviso, il terrore di Arzamàs gli si commosse dentro: i piccoli oggetti quotidiani incarnavano l'orrore; ciò che era fisico suscitava uno spavento metafisico. «Dio mio! Come farò a pernottare qui dentro?» pensò. Per salvarsi, decise di andare a teatro con un amico: si infilò la rigida, gelida camicia inamidata, abbottonò i polsini, indossò la redingote, calzò le scarpe nuove. A teatro, mentre vedeva il Faust, e dopo teatro, al ristorante, il tempo passò piacevolmente: l'angoscia di Arzamàs sembrava dimenticata.
Passò una nottata terribile: peggiore di quella di Arzamàs. Soltanto la mattina si addormentò; e non sul letto, dove aveva provato invano a stendersi tante volte, ma sul divano. Tutta la notte aveva sofferto in maniera intollerabile: di nuovo, tormentosamente, si dilacerava l'anima dal corpo. «Io vivo — pensava — ho vissuto, vivrò ancora; e tutt'a un tratto, la morte, l'annientamento di ogni cosa. A che scopo, dunque, vivere? Morire? Uccidersi subito? Mi fa paura. Vivere, allora. Ma a che scopo? Per morire?». Non usciva da questo circolo. Pregava Dio: «Se tu esisti, rivelami dunque: a che scopo, cosa sono io?». Si curvava a terra, recitava quante preghiere sapeva, ne componeva di sue, e poi soggiungeva: «Rivelami dunque!». E restava in silenzio, in attesa d'una risposta. Ma risposta non c'era, come se non ci fosse, neppure, qualcuno che potesse rispondergli.
Nelle ultime pagine delle Memorie di un pazzo, qualcuno risponde al protagonista e a Tolstoj: ci sono le Scritture, le vite dei santi, il pane consacrato, i mendicanti. Finisce, o finisce per qualche tempo, l'angoscia e il timore. Da lontano, Dio invia la sua luce, e salva Tolstoj dalla disperazione e dalla morte. Così, diventa l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Questo Dio è una X, un come se, un'incognita: «ma sebbene il significato di questa X ci sia sconosciuto — insiste Tolstoj — senza questa X non si può cercare di risolvere, ma neppure porre nessuna equazione».
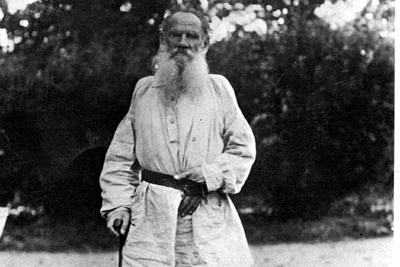
Nessun commento:
Posta un commento